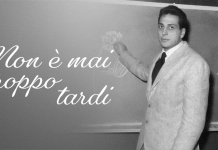Ci sono quadri che diventano famosi per la loro bellezza, e poi c’è la Gioconda, che è diventata famosa per tutto ciò che le è successo attorno. È questo il paradosso irresistibile, fastidioso, un po’ comico che continua a trasformare il dipinto più celebre del mondo in un fenomeno mediatico più che artistico. Un quadro che, suo malgrado, si è visto cucire addosso un mito più pesante della cornice che lo protegge.
Il colpo di scena iniziale ha un nome e un cognome: Vincenzo Peruggia. Un italiano convinto erroneamente che Napoleone avesse trafugato la Gioconda, e quindi deciso a “restituirla” alla patria. Nel 1911 la ruba e sparisce. Il mondo va in tilt: giornali, caricature, teorie. Quando il quadro riaffiora a Firenze, la sua fama è già elettrica. L’esposizione italiana, il ritorno in Francia, il clamore internazionale: tutto contribuisce a creare l’aura del capolavoro irripetibile. In realtà, Leonardo la vendette regolarmente a Francesco I nel Cinquecento: nessuna razzia napoleonica, nessun saccheggio. Ma il mito, si sa, corre più veloce dei fatti.
Il resto lo fa il Novecento: fiumi di inchiostro, studi, fino al boom planetario del Codice da Vinci, che trasforma il ritratto in un rebus pop. Da quel momento in poi, la Gioconda diventa più un’icona che un dipinto.

Ed eccoci al punto dolente. Il Louvre è il museo che custodisce alcune delle esperienze estetiche più intense al mondo. Eppure la metà dei visitatori entra, si orienta come in un aeroporto e si lancia verso la sala della Monna Lisa con la stessa compostezza di un fan che rincorre la star del momento. Non c’è tempo per guardare il quadro: c’è solo tempo per farsi un selfie. Un esercito di braccia alzate, telefoni che scintillano, un mormorio continuo. Il risultato? Davanti al dipinto più celebrato del pianeta, l’unica cosa impossibile da fare è… ammirarlo. Il paradosso è che, mentre la Gioconda viene assediata come un’attrazione da parco a tema, il resto del Louvre rimane sorprendentemente vivibile. E lì, proprio lì, si trovano opere che molti storici dell’arte considerano superiori alla celebre donna con il sorriso sospeso. Leonardo stesso, nelle altre sale, dispensa meraviglie che rischiano di mandare in overdose emotiva chiunque soffra anche solo lontanamente della sindrome di Stendhal.

Ma il discorso non riguarda solo Leonardo. Il museo trabocca di capolavori italiani: Giotto, Vasari, Perugino, Canova, Botticelli… Una diaspora del genio che ricorda, ogni volta, quanto l’Italia sia stata un motore artistico planetario. Il vero problema, semmai, è la gestione. Troppa gente, troppe sale stipate, troppi gruppi chiassosi: il Louvre vive una contraddizione radicale. È un tempio dell’arte schiacciato dall’industria del turismo. Le opere sono lì, immobili e magnifiche, ma il tempo necessario per comprenderle evapora nelle code, nelle spinte, nei commenti ad alta voce. L’arte, invece, ha bisogno di silenzio e di osservazione. Ha bisogno di essere vissuta, non consumata. Non è questione di snobismo: è questione di rispetto. Per chi guarda e per ciò che viene guardato.

E il paradosso resta questo: in un museo che richiederebbe tre giorni solo per essere sfiorato, la gente ci passa tre minuti. Uno per la coda, uno per la foto, uno per scappare via.