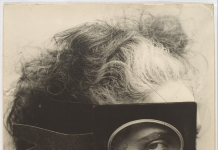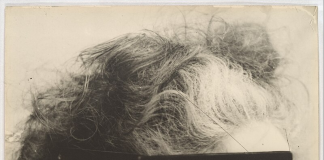Cecco d’Ascoli, il cui vero nome era Francesco Stabili, è una figura affascinante e controversa del Medioevo italiano. Le sue origini sono ad Ascoli Piceno, città identitaria, anche se non era nato proprio nella città marchigiana, ma ad Ancarano, a pochi chilometri da Ascoli e oggi in provincia di Teramo. La sua data di nascita non è certa, e viene oggi stimata intorno al 1269. Contemporaneo di Dante Alighieri, è considerato anzi l’anti-Dante per eccellenza, e la sua opera più famosa, “L’Acerba” sarebbe una anti-Commedia, ed è ricordato come poeta, astrologo, medico e filosofo, ma anche come vittima della repressione religiosa del suo tempo. Un aspetto che specialmente nell’Italia del Risorgimento lo fece ascendere all’olimpo dei miti fondanti di una nazione in cui l’anticlericalismo innalzava come bandiere le vittime dell’Inquisizione e i nemici del potere temporale dei papi, da Cola di Rienzo a Giordano Bruno, da Graziano a Galileo. La sua vita, segnata da un’intensa attività intellettuale e da un tragico epilogo, è comunque al centro delle tensioni culturali e religiose dell’Italia del XIV secolo.
La vita e le opere
Cecco d’Ascoli si formò probabilmente a Bologna, dove approfondì gli studi di medicina, filosofia e astrologia, discipline che lo resero una figura di spicco nel panorama culturale dell’epoca. La sua opera più celebre è “L’Acerba” (o “Acerba etas” anche se c’è chi vi vuol vedere un riferimento a un animale alchemico, “La cerva”), un poema didascalico in volgare che si proponeva come una summa del sapere scientifico, filosofico e morale del tempo. Scritto in sestine di endecasillabi, il testo è una sorta di enciclopedia del sapere del suo tempo, trattando temi che spaziano dall’astronomia alla teologia, dalla morale alla cosmologia. A differenza della Commedia di Dante, con cui Cecco è spesso confrontato, “L’Acerba” non racconta un viaggio fantastico, ma cerca di spiegare il mondo attraverso un approccio razionale e scientifico, a dimostrazione che il Medioevo fu tutt’altro che un’età “oscura”, ma un ribollire di ricerca della conoscenza anche e soprattutto grazie alla Scolastica di San Tommaso e alla rinascita dell’aristotelismo.
Cecco tuttavia pagò pegno alla sua passione per l’astrologia, scienza che fino al 1700 era tutt’uno con l’astronomia, campo in cui fu rinomato e che gli valse sia ammirazione che sospetti. Infatti l’astrologia era guardata con diffidenza dalla Chiesa, che vedeva in certe interpretazioni più deterministiche degli oroscopi un tentativo di limitare l’onnipotenza divina e il libero arbitrio concesso dal Signore agli uomini (se infatti la vita degli uomini è influenzata dagli astri, dove risiederebbe il libero arbitrio? Un problema teologico scottante). Egli insegnò astrologia a Bologna e, successivamente, lavorò come medico e astrologo alla corte di Firenze, dove entrò in contatto con figure di spicco come il poeta Cino da Pistoia.
Le controversie e il rapporto con Dante
Cecco d’Ascoli è noto anche per la sua rivalità con Dante Alighieri, che criticò aspramente anche se pare che il rapporto con il Sommo Poeta non fosse improntato all’inimicizia. Piuttosto pare che la loro fosse una disputa intellettuale. Le sue critiche riguardavano sia lo stile poetico di Dante sia alcune sue posizioni filosofiche e teologiche. In particolare, Cecco disapprovava l’approccio allegorico della Commedia, preferendo un linguaggio più diretto e scientifico: in questo senso va interpretato il celeberrimo verso “Qui non si canta al modo delle rane”, ripreso poi dai Futuristi come epigrafe della loro rivista, che a sua volta riprendeva il nome dal poema di Cecco, “Lacerba”.
L’accusa di eresia e la condanna
La vita di Cecco fu segnata da conflitti con le autorità religiose. Nel 1324, a Bologna, fu accusato una prima volta di eresia per alcune sue affermazioni astrologiche, incompatibili con la dottrina cristiana. Fu costretto a ritrattare e a lasciare Bologna. Nel 1327, trasferitosi a Firenze, Cecco fu nuovamente processato dall’Inquisizione. Questa volta le accuse furono più gravi: oltre alle sue teorie astrologiche, gli furono imputate affermazioni considerate blasfeme, in particolare in tema di demonologia, materia particolarmente scottante in quell’epoca. Il processo si concluse con una condanna al rogo ma non sono sopravvissuti documenti che attestino i veri motivi (si parla anche di una possibile vendetta delle famiglie di Dante Alighieri e Guido Cavalcanti). In ogni caso, sembra che durante il processo Cecco abbia pervicacemente difeso il proprio pensiero con una frase passata alla storia: «L’ho detto, l’ho insegnato, lo credo!», rifiutando di abiurare e dunque affrontando coscientemente il rogo. Il 16 settembre 1327, Cecco d’Ascoli fu bruciato vivo in Piazza della Signoria a Firenze. Presto attorno alla sua figura si crearono miti e leggende e passò alla storia non solo come martire del libero pensiero ma anche come mago e demonologo, perfino in grado di evocare i diavoli e farsi obbedire da loro… Non per caso del ponte romano di Ascoli si racconta che Cecco fosse riuscito a costringere un diavolo a costruirlo in una sola notte, mentre un altro racconto su di lui gli attribuisce addirittura il taglio delle Gole del Velino, dove la Salaria proveniente da Roma giunge ad Ascoli, sempre attraverso l’invocazione di un potere diabolico che avrebbe tagliato le rocce rosse dell’Appennino per passare oltre la strada bloccata da una frana.