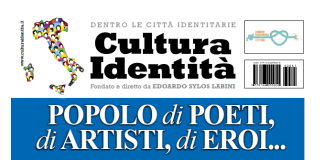Il quartiere di Basiglio incarna i principi su cui la SIMA fonda la propria missione: salute, prevenzione, sostenibilità, benessere ambientale
Milano 3 non è soltanto un quartiere residenziale alle porte di Basiglio, è un manifesto urbanistico, un laboratorio sociale, un frammento di futuro progettato in un tempo in cui il futuro stesso sembrava ancora distante. Quando, alla fine degli anni Settanta, Silvio Berlusconi, sulla scorta di quanto già realizzato con Milano 2, ne intuì la necessità e ne volle la realizzazione, nessuno parlava ancora di «città dei quindici minuti», di diritto alla natura o di linee guida urbanistiche che oggi raccomandano di vivere a non più di 300 metri da un’area verde di almeno 5.000 metri quadrati. Nessuno citava la regola del 3-30-300, secondo cui ogni cittadino dovrebbe vedere almeno tre alberi dalla propria finestra, vivere in un quartiere con almeno il 30% di copertura arborea e abitare come detto a non più di 300 metri da uno spazio verde. Eppure quell’idea era già impressa nella sua visione: creare un luogo in cui la bellezza, il benessere e la qualità della vita non fossero un lusso riservato a pochi, ma un diritto quotidiano, accessibile a chiunque scegliesse di vivere lì.
Lo sviluppo di Milano 3 fu affidato a Edilnord, la società immobiliare del Cavaliere. L’ambizione era chiara: non soltanto «costruire case», ma plasmare un ambiente, disegnare uno stile di vita, dare forma a un modello di convivenza in cui le persone potessero crescere, lavorare, incontrarsi e rigenerarsi. Il progetto si ispirava alle città-giardino anglosassoni, adattandole al contesto lombardo e alla cultura italiana, fatta di piazze, di relazioni e di convivialità. L’architettura degli edifici, razionale e sobria, era intrecciata a una cura quasi ossessiva del verde. A trasformare l’urbanistica in ecologia quotidiana furono introdotti parchi, giardini e percorsi alberati come vere e proprie infrastrutture di benessere. Il verde non era una cornice, ma la struttura portante: laghetti, filari, piazze naturali e connessioni pedonali che permettevano a chiunque, uscendo di casa, di ritrovare la bellezza di uno spazio vivo, respirabile, sociale. Oggi potremmo definirlo un quartiere biofilico, ante litteram. Camminando lungo i viali alberati di Milano 3, costeggiando i laghetti abitati da cigni e anatre, ci si accorge che la natura non è un contorno, ma la trama stessa della vita quotidiana. Ogni residenza è stata concepita per avere a pochi passi un grande spazio verde, luogo di gioco per i bambini, di sport all’aria aperta, di incontro intergenerazionale.
Le strade interne, progettate per limitare il traffico automobilistico, aumentano la percezione di sicurezza, riducendo il rischio di incidenti e favorendo la socialità spontanea. Un concetto che oggi appare evidente, ma che allora era radicalmente innovativo, l’idea che la salute pubblica non si tuteli soltanto negli ospedali, ma soprattutto nel modo in cui progettiamo i nostri quartieri, nel tempo che passiamo all’aperto, nella qualità dell’aria che respiriamo e nei luoghi in cui intrecciamo relazioni. A distanza di oltre quarant’anni, ciò che allora poteva sembrare un azzardo immobiliare si rivela come una straordinaria anticipazione culturale. La letteratura scientifica di oggi è unanime: vivere vicino al verde riduce lo stress, abbassa i livelli di cortisolo e rafforza le difese immunitarie. Una revisione pubblicata su «The Lancet Planetary Health» ha mostrato che vivere entro 300 metri da uno spazio verde riduce fino al 16% il rischio di depressione e fino al 25% quello di ansia cronica. Uno studio condotto in Danimarca su oltre 900 mila bambini ha rivelato che crescere in aree verdi riduce del 55% il rischio di sviluppare disturbi psichiatrici in età adulta. Altri lavori dimostrano che la vicinanza alla natura può persino allungare l’aspettativa di vita di 2-3 anni, oltre a contribuire a ridurre le disuguaglianze di salute tra quartieri ricchi e periferie svantaggiate.
Gli effetti non riguardano solo la salute mentale. Studi statunitensi hanno dimostrato che un aumento del 10% della copertura arborea urbana si associa a un calo fino al 12% dei tassi di criminalità. A Philadelphia, la rigenerazione dei lotti abbandonati con la creazione di aree verdi ha portato a una diminuzione del 29% dei crimini violenti nelle aree circostanti. Anche la percezione di sicurezza cresce: le persone si sentono più protette in spazi curati, vissuti e condivisi. È il principio, oggi consolidato, che la cura del paesaggio urbano diventa cura della comunità.
Milano 3 ha incarnato, inconsapevolmente, un principio che oggi la psicologia ambientale e la medicina urbana considerano indiscutibile: il verde urbano non è un ornamento estetico, ma un vero e proprio farmaco naturale, senza effetti collaterali. Favorisce la coesione sociale, incoraggia l’attività fisica, riduce la solitudine, stimola empatia e senso di appartenenza. Camminare in un quartiere alberato non solo migliora l’umore, ma spinge le persone a parlarsi di più, a riconoscersi parte di una comunità. E laddove esiste comunità, si riducono i conflitti, aumentano l’inclusione, le reti di sostegno reciproco e la resilienza collettiva. Quella di Milano 3 fu dunque una lezione di urbanistica preventiva, ben prima che fossero introdotte linee guida e policy internazionali per città più sane e vivibili. Berlusconi comprese che un quartiere immerso nel verde poteva diventare il miglior alleato della salute pubblica: uno spazio in cui lo sport, la rigenerazione e la bellezza quotidiana fossero parte integrante della vita di ciascuno. Il suo progetto rese tangibile ciò che oggi è una certezza scientifica: la natura in città riduce le spese sanitarie, aumenta la produttività sul lavoro, stimola creatività e innovazione. Secondo l’OMS, ogni dollaro investito in infrastrutture verdi può generare fino a 4 dollari di risparmio sanitario e costi sociali evitati. Se oggi parliamo di «diritto alla natura», di parchi accessibili come terapie per il corpo e la mente, di urbanistica come medicina preventiva, dobbiamo riconoscere che già allora un uomo ebbe il coraggio di progettare la vita quotidiana intorno al benessere.
Milano 3 rimane così un simbolo potente, la dimostrazione che quando l’impresa incontra la cultura del paesaggio e la responsabilità sociale, nasce qualcosa che non invecchia ma diventa patrimonio collettivo. Silvio Berlusconi, in quell’impresa, non costruì soltanto case, costruì un’idea di futuro. Un’idea che a distanza di decenni continua a parlarci, mostrando come la visione possa precedere la scienza e come l’urbanistica, quando è guidata dal desiderio di benessere, possa trasformarsi nella più concreta delle eredità. Per questi motivi, e per il valore simbolico e anticipatore che Milano 3 continua a rappresentare nel panorama urbanistico e culturale italiano, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha scelto, nel suo decennale, proprio questo quartiere come propria sede lombarda. Una decisione profondamente coerente: Milano 3 incarna infatti i principi su cui la SIMA fonda la propria missione – salute, prevenzione, sostenibilità, benessere ambientale – trasformando la visione di allora in una realtà ancora oggi esemplare per le città del futuro.