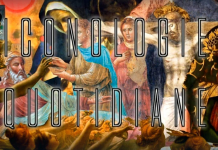“Auto-strada”. Un nome che a noi vivi del XXI secolo dice poco e fa parte del quotidiano. Beh, normale che le strade servano per le automobili, no? Un’idea che cento anni fa esatti era del tutto innovativa. Del resto a circolare per le strade erano soprattutto carri trainati da quadrupedi, calessi, biciclette, pedoni. Le automobili erano pochissime: 57.000, una ogni 672 abitanti (oggi il rapporto è due auto ogni tre italiani). Per fare un confronto, in Inghilterra circolavano quindici volte le automobili dell’Italia, in Francia otto.
Così quel 21 settembre 1924, quando venne inaugurato il primo tratto di una “auto-strada” si pose una pietra miliare storica nell’evoluzione dei trasporti. Per la prima volta nel mondo si apriva un asse viario esclusivamente dedicato al traffico motorizzato: la Milano-Laghi.
L’idea era di un imprenditore privato, il milanese Piero Puricelli (1883-1951). Ingegnere (anche se amava definirsi “ingegnere architetto”), Puricelli concepì la strada dopo aver dato vita, l’anno precedente, all’autodromo di Monza, il terzo circuito automobilistico del mondo. Anche quella un’opera da record, realizzata nel 1922 su richiesta dell’Automobile Club d’Italia in soli 110 giorni. Il progetto fu stilato da Puricelli insieme al collega ingegnere Alfredo Rosselli.
L’autostrada venne ideata in quello stesso anno. Puricelli aveva una ditta specializzata in lavori stradali (Società Puricelli cave e strade) che aveva collaborato col Genio Militare durante la Grande Guerra, consolidandosi. Alla fine del conflitto Puricelli aveva trasformato l’esperienza maturata in guerra in un corso di ingegneria stradale al Politecnico di Milano. Nel 1920, convinto oramai che il destino del veicolo a trazione animale sarebbe stato d’essere presto sostituito da quello a motore, Puricelli comincia a studiare l’opportunità di “costruirgli una strada non interessata da altre vie, con caratteristiche geometriche, tecniche e strutturali idonee per esplicare le prestazioni di velocità e di portata con la maggiore garanzia di sicurezza”. Naturalmente sa bene che “l’autostrada dovrà farsi solamente ove siano le condizioni di ambiente e di traffico motivanti la giustificazione di una somma corrispondentemente congrua di utilità economica generale”, ed è per questo che il luogo naturale in cui sarebbe sorta la sua creatura non poteva che essere la Lombardia, regione in cui circolava quasi metà del parco motorizzato nazionale.
Puricelli era consapevole che la creazione di una “coscienza stradale nel nostro paese” avrebbe favorito la motorizzazione dell’Italia e – a ricaduta “l’intensificarsi degli scambi, dei commerci, del turismo; che la costruzione di infrastrutture stradali avrebbe alleviato la disoccupazione, diminuito gli incidenti, allungato la vita media dei veicoli, reso più economici gli spostamenti, fatto dell’automobile un mezzo di trasporto alla portata, se non di tutti, di molti”, ha scritto nel 2003 Donatella Biffignandi del Museo dell’Automobile.
Fra gennaio e marzo 1922 l’ACI e il Touring creano un comitato per valutare la proposta di Puricelli, che l’approva all’unanimità. L’impresa viene costituita sul modello di quella delle concessioni ferroviarie: lo Stato dà la concessione, il privato realizza e si ripaga il lavoro con i proventi di gestione (pedaggi, pubblicità, etc.). Dopo cinquant’anni lo Stato diviene proprietario dell’infrastruttura. Nel settembre-ottobre 1922 la crisi di governo in Italia giunge alla soglia della guerra civile e Mussolini viene chiamato al potere. Patricelli riesce a ottenere dal nuovo presidente del Consiglio un incontro a un paio di settimane dalla Marcia su Roma e lo convince della bontà del suo progetto. Mussolini gli accorda ogni appoggio comprendendo subito l’importanza anche morale e propagandistica dell’idea. Un mese dopo Puricelli crea una società, ottiene il riconoscimento della “pubblica utilità” per la sua opera (con la quale può procedere agli espropri necessari per la sua realizzazione) e si impegna a chiudere i lavori entro il 1925. Vengono espropriati complessivamente 300.000 mq di terreno da tremila proprietari, risarciti con sei milioni di lire dell’epoca, e il 26 marzo 1923 Mussolini può dare il simbolico “primo colpo di piccone”, accompagnato da una serie di facilitazioni economiche tutt’altro che simboliche, ma che senza soverchio impegno finanziario per le casse dello Stato (era quella la fase “liberista” del governo di Mussolini) metteva a disposizione pubblica un’opera strategica con la prospettiva di entrarne in possesso diretto nel giro di due generazioni. In realtà il mutato scenario economico provocato dalla crisi del ’29 spinse il Regime a nazionalizzare la Milano-Laghi già all’inizio degli anni Trenta, mentre lo Stato avviava la realizzazione della prima autostrada pubblica a pedaggio – la Genova-Serravalle Scrivia – nel 1932.
Nel frattempo, il termine italiano “autostrada” era diventato globale: nel 1926 il Congresso mondiale della Strada si era tenuto, significativamente, proprio a Milano e l’aveva imposto come standard (con le opportune traduzioni: Autobahn in tedesco). L’esempio italiano aveva aperto la via alle altre nazioni. C’erano stati casi precedenti alla Milano-Laghi, per esempio i circuiti Long Island Motor Parkway e Bronx River Parkway nello Stato di New York, aperte al traffico rispettivamente ne 1908 e 1922 e la AVUS nella periferia di Berlino, progettata nel 1909 e inaugurata nel 1921, ma queste tre esperienze erano nate come circuiti ricreativi, per la “guida panoramica” o sportiva. La circolazione “solo-motorizzate” era un sottoprodotto del progetto.
La Milano-Laghi invece era concepita esclusivamente per il traffico motorizzato, con lunghi rettifili, curve dolci (non più strette di 400 metri), pendenze mai superiori al 3%. La strada non aveva immissioni secondarie e quindi il traffico poteva scorrere senza dover dare precedenze. Inoltre si introduceva il concetto di strada “a pedaggio”, anche se inizialmente il pagamento non avveniva coi caselli, ma alla stazione di servizio (tappa obbligatoria per gli utenti). La pavimentazione della Milano-Laghi non era in asfalto (tecnologia maturata successivamente), ma in calcestruzzo e nei primi anni la strada osservava un orario d’esercizio limitato alle ore diurne, con chiusura fra l’1 di notte e le 6 di mattina.
Il 21 marzo del 1924, a meno di un anno dal primo colpo di piccone, l’ingegner Puricelli, alla presenza di sua maestà Vittorio Emanuele III, inaugurava il primo tratto di 50 km, da Milano a Varese. L’anno successivo, con quattro mesi d’anticipo sull’impegno preso col governo, Puricelli completava la terza tratta, Gallarate-Sesto Calende. Negli anni successivi sarebbero state aperte altre autostrade (la prima pubblica: Roma-Lido, con illuminazione elettrica, nel 1928) mentre Puricelli veniva ammesso al laticlavio senatoriale per regio decreto nel 1929. La sua esperienza lo condusse in commissione Affari dell’Africa Italiana, visto l’impegno profuso nelle colonie per la realizzazione di una rete viaria, sul solco dell’esempio romano. Puricelli concepì in quegli anni anche un’idea di rete autostradale europea, suggestione che venne ripresa oltralpe da Adolf Hitler, che con la sua mastodontica rete delle Autobahnen creò la prima infrastruttura strategica del Terzo Reich alla metà degli anni Trenta, risollevando keynesianamente l’economia disastrata della Germania di Weimar.
Puricelli fu coperto di riconoscimenti in patria e all’estero: onorificenze, cavalierati, lauree honoris causa. L’idea dell’autostrada rivoluzionò il mondo industrializzato, mostrando al mondo che il genio italiano, quando non è ostacolato dalla burocrazia, è il faro del mondo.