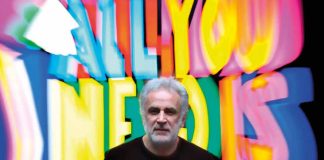Era la notte dell’8 ottobre 1815 quando, a bordo di una feluca malconcia, l’ormai ex re di Napoli Gioacchino Murat, maresciallo di Francia e cognato di Napoleone, sbarcò sulle spiagge di Pizzo (Vibo Valentia), credendo che il popolo, grato per le sue riforme, si sarebbe rivoltato contro i Borbone restaurati. Ma l’alba portò solo catene. Murat fu arrestato dai soldati borbonici, processato in un’udienza lampo e condannato a morte.
Murat affrontò la sorte con il coraggio che si deve a una carriera come la sua: chiese carta e inchiostro per l’ultima lettera alla moglie Carolina e ai figli, dettandola in francese con mano ferma, e vi allegò ciocche dei suoi capelli neri, simbolo di un addio intimo e fiero. Poi, si confessò e comunicò, chinando il capo non per timore divino, ma per un’ultima riconciliazione con l’anima.
Al cospetto del plotone, nel fossato del castello di Pizzo, Murat si erse con la camicia slacciata, ultimo gesto guascone, rifiutando la benda sugli occhi. “Amici miei, sono io a comandare il fuoco: mirate al petto e risparmiate il volto!”, gridò con voce di tuono, offrendo il torace. Due colpi fallirono, tra i singhiozzi dei militi commossi; la seconda scarica, precisa, lo abbatté alle soglie dei quarantotto anni. Il suo ultimo desiderio non fu accolto, perché nonostante abbattuto da sei palle al torace, fu finito dal capo-plotone con due colpi alla testa.
Perché Murat aveva deciso di sbarcare in Calabria? Era davvero convinto che il popolo calabrese l’avrebbe seguito contro i Borbone? C’è chi sospetta il “trappolone”, teso dai servizi austriaci, napolitani e inglesi per liberarsi di un personaggio pericoloso per la restaurazione: del resto a spingerlo all’impresa fatale era stato proprio il suo ex aiutante di campo, l’ambiguo colonnello inglese Francis Macirone, e da due messi di Luigi de’ Medici, ministro del re Ferdinando di Borbone-Napoli, che gli avevano prospettato possibilità di successo proprio nella terra da cui erano partite le contro-rivoluzioni sanfediste un ventennio prima. Murat, in esilio in Corsica, aveva poi radunato una compagnia di appena 250 uomini e con cinque navi cercò di raggiungere la Calabria. Un fortunale disperse la flottiglia e – guarda caso – solo la nave dell’ex maresciallo di Francia rimase in rotta. Alla fine, lo stesso Murat disperò della possibilità di successo e ordinò al comandante della sua nave, un maltese, di far rotta verso Trieste. Inutilmente: il capitano lo fece sbarcare col suo piccolo manipolo a Pizzo, in pieno giorno di mercato (era domenica).
L’epilogo, come detto, durò pochi giorni. Napolitani e inglesi lo volevano morto a ogni costo. Con albionica spregiudicatezza, l’ambasciatore di Londra, William A’Court, sentenziò: “Ammazzatelo, me ne assumo la totale responsabilità”. I napolitani istituirono una commissione giudicante con la sentenza già scritta. Solo gli austriaci, ligi al rispetto di corte dovuto a chi, bon gre mal gre, era comunque imparentato con la famiglia imperiale (in quanto cognato dell’imperatrice Maria Luisa d’Asburgo-Lorena, seconda moglie di Napoleone e figlia dell’imperatore d’Austria, Francesco II d’Asburgo-Lorena), avrebbero preferito un finale diverso. Ma furono ignorati. Dopo quattro notti passate in una cella sotterranea del castello di Pizzo, Murat venne sommariamente processato, gli fu concessa mezz’ora per i conforti religiosi e poi condotto davanti al plotone d’esecuzione. Il suo contegno è entrato nella storia: quel “mirate al petto” è oramai proverbiale per ogni “bella morte” che si rispetti. Il suo corpo venne poi sepolto in una fossa comune presso la chiesa di San Giorgio, sempre a Pizzo, ed è tutt’ora irriconosciuto.
Napoleone, nelle sue memorie, commentò aspramente la fine del cognato, che non aveva mai davvero stimato umanamente. Aveva dovuto tollerare le nozze con la sua amata sorella Carolina, per la quale avrebbe preferito un matrimonio politico e non d’amore. Lei, invece, era rimasta folgorata dal vigoroso cavaliere trentaduenne che le si era presentato sotto le finestre nel 1799 per annunciarle il successo del colpo di Stato di Napoleone, il 19 brumaio (10 novembre). La piccola ma graziosa diciassettenne ottenne due mesi dopo – non senza fatica – il permesso dal tirannico fratello-capofamiglia per convolare a nozze col gigantesco maresciallo. Fu dunque un matrimonio d’amore (anche se punteggiato di scappatelle) coronato da quattro figli verso i quali Gioacchino manifestò sempre sollecitudine e amore paterno, testimoniato dalle tenere lettere per la secondogenita Letizia. Ascesi poi a ruoli sempre più importanti nella nuova gerarchia napoleonica, finirono sul trono di Napoli, soprattutto per l’ascendente che Carolina aveva sul fratello imperatore: “Lasciami fare, bestione, fra poco sarai re!”, pare le dicesse la risoluta moglie. Nel 1808 Gioacchino e Carolina sedevano sul trono di Napoli. Un regno breve ancorché non privo di politiche intelligenti e riforme durature, segno che il maresciallo francese s’era davvero preso a cuore la sorte dei cittadini-sudditi a lui assegnati. Addirittura Murat cercò di infrangere il blocco continentale imposto da Napoleone alle merci inglesi, perché danneggiava il suo regno. Bonaparte lo minacciò di ghigliottina.
Ma altre tragedie avrebbero spinto al finale: la disastrosa campagna di Russia, con Murat lasciato da Napoleone a condurre i resti della Grande Armata decimata dall’inverno e dalla strenua resistenza russa, poi la Battaglia delle Nazioni a Lipsia. Dopo questa definitiva disfatta, Murat decise di sfilarsi, addirittura portando il suo regno nella Coalizione antinapoleonica. Un tradimento che fu mal pagato dai suoi sedicenti nuovi alleati: inglese e austriaci lo dichiararono deposto senza tanti complimenti per restaurare Ferdinando di Borbone. A quel punto Murat, proprio mentre il cognato dall’esilio dell’Elba sbarcava in Provenza per i suoi folgoranti Cento Giorni, giocò la sua ultima carta: proclamò la libertà d’Italia e incitò i popoli della penisola a unirsi sotto la sua bandiera per combattere il giogo austriaco. Che fosse una disperata mossa o un sincero gesto d’amore per la nazione di cui era stato re, quantomeno nella sua metà meridionale, per sette anni, non è dato sapere. Quel che è certo è che il suo proclama di Rimini del 30 aprile 1815 è a buon diritto considerato il seme del nostro Risorgimento. E, ironia della storia, così come era stato un italiano a dare ai francesi il loro impero, ora era un francese che dava agli italiani la scintilla della propria indipendenza.