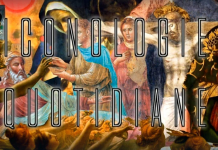Con la scomparsa di Pippo Baudo il 16 agosto 2025, si chiude un’era della televisione italiana durata oltre sessant’anni. Baudo fu la guida discreta e ingombrante della televisione italiana, capace di conservarne il fascino senza mai cercare effetti speciali o clamore.
Pippo Baudo ha raccontato un Paese, e così facendo, lo ha reso reale. Con la morte di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025, se ne va non solo il volto più iconico della TV italiana, ma una delle sue anime. In questo ritratto si ripercorrono le tappe della sua carriera: l’invenzione di una TV “popolare” nel senso più alto, l’influenza sui consumi, la vocazione artistica e la capacità unica di far coincidere la leggerezza con la dignità.
L’uomo che ha inventato la televisione popolare
È morto il 16 agosto 2025. La notizia è passata rapida, tra una rassegna stampa e un post. Se c’è un nome che ha accompagnato l’Italia televisiva per più di mezzo secolo, è il suo: Pippo Baudo.
Baudo non fu il più colto, né il più moderno. Ma fu il più affidabile. La sua forza era quella di chi capisce il pubblico prima ancora che il pubblico capisca se stesso.
Nei primi anni Sessanta, in una Rai ancora inamidata e pedagogica, lui portava una forma diversa di sobrietà: non quella dell’austerità, ma quella della confidenza.
La svolta arriva, come spesso accade, per sbaglio. Una bobina smarrita costringe la Rai a mandare in onda un programma ancora da collaudare: Settevoci. È il 1966. L’Italia ascolta, e si riconosce. Perché Settevoci non è solo una gara tra giovani e applausi. È la prima trasmissione che parla come parlano le famiglie, che sorride come sorride la domenica.
Da lì in poi, è una sequenza di tappe che definiscono non solo una carriera, ma un’epoca: Canzonissima, Fantastico, Domenica In, Serata d’onore, Novecento. In ognuno di questi programmi, Baudo è regista e cerimoniere, arbitro e custode. Sempre con discrezione, sempre con misura.
Il vertice è il Festival di Sanremo, che conduce tredici volte tra il 1968 e il 2008, in sette edizioni anche da direttore artistico.
Più che un conduttore, è un garante. Sul palco dell’Ariston, Baudo non intrattiene: orchestra. Tiene insieme sponsor e cantanti, giurie e televoto, fischi e standing ovation. Fa in modo che ogni edizione, anche la più travagliata, si concluda con dignità. E questo, in Italia, non è poco.
Naturalmente non tutto riuscì. Nel 1987 lasciò la Rai per Mediaset, più per motivi economici che artistici. I programmi – La canzone del secolo, Tiramisù – fallirono. Non era il pubblico ad averlo tradito. Era il contesto a essere sbagliato. Baudo fuori dalla Rai era come un vigile in costume da bagno: fuori posto. Tornò a Viale Mazzini, e con Novecento e Domenica In riprese il filo.
Perché la sua forza non era in un format. Era in un modo. La televisione popolare che aveva inventato – fatta di ritmo, calore, ordine e affidabilità – non si insegnava. Si incarnava. E Baudo ne fu il corpo e la voce per sessant’anni.
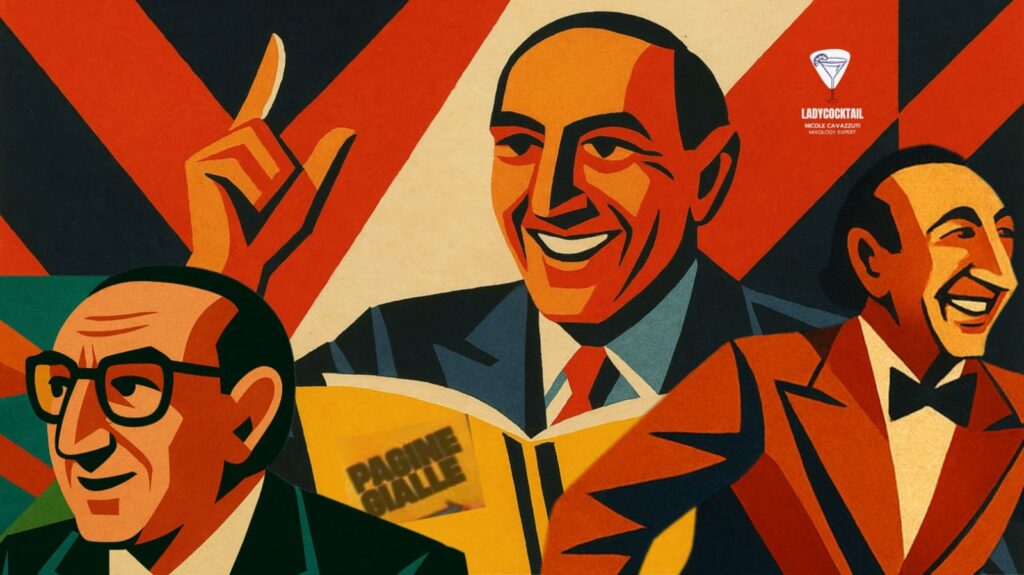
L’uomo che influenzava i consumi
Non si è mai definito un pubblicitario, ma i suoi effetti lo furono eccome.
La gente non comprava un prodotto perché lo vedeva in uno spot. Lo comprava perché lo vedeva nei suoi programmi. Non consigliava: legittimava.
Nel decennio d’oro tra gli anni Settanta e Ottanta, Fantastico e Domenica In erano appuntamenti sacri.
Milioni di italiani guardavano. Ascoltavano. Commentavano. E intanto, bevevano il caffè consigliato, la bibita sponsorizzata, il liquore della sera. Senza saperlo, Baudo influenzava la spesa, lo stile, le scelte.
Era quello che oggi si chiamerebbe un influencer. Ma senza selfie e senza social. Bastava uno sguardo, un’introduzione, una pausa.
E l’oggetto diventava familiare, desiderabile, normale. In questo senso, Baudo fu anche un educatore involontario del consumo di massa.
Trasformò le marche in parole note, e gli italiani in spettatori consapevoli, ma non diffidenti.
Un equilibrio delicato, che pochi riuscirono a mantenere.
L’uomo artista
C’era anche un’altra parte, meno nota, della sua figura: quella del paroliere.
Baudo scrisse canzoni. E non solo. Donna Rosa, cantata da Nino Ferrer, era sua. Così come Una domenica così, affidata alla voce di Gianni Morandi. Canzoni semplici, popolari, ma mai banali. Come le sue trasmissioni.
Ma l’arte di Baudo non stava solo nei testi. Stava nel ritmo, nella conduzione, nella regia invisibile. Sapeva quando tagliare, quando allungare, quando lasciare che fosse il pubblico a decidere. Era un presentatore, sì. Ma con i tempi di un attore e l’occhio di un direttore d’orchestra.
Fu anche talent scout. E lì non sbagliava quasi mai. Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Giorgia, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Beppe Grillo, Eros Ramazzotti: sono solo alcuni dei nomi passati dal suo fiuto.
Il “nazionalpopolare” secondo Pippo Baudo
Nel 1987, durante una puntata di Fantastico 7, il presidente della Rai Enrico Manca utilizzò per la prima volta in senso spregiativo il termine “nazionalpopolare”, definendo così la trasmissione condotta da Baudo e suggerendo che fosse volgare e priva di dignità culturale. La risposta, pungente, di Baudo fu: “Considero questa definizione un’offesa… Vuol dire che d’ora in poi farò programmi regionali e impopolari.”
Ironia della sorte, nel 1996 lo stesso Baudo rivendicò con orgoglio l’etichetta, definendo il Festival di Sanremo “uno spettacolo nazionalpopolare nel senso gramsciano del termine”. In tal modo, trasformò un’etichetta inizialmente dispregiativa in una chiave di legittimazione culturale, assimilando il suo operato alla ricerca gramsciana di una forma di cultura che fosse insieme popolare e nazionale.
E oggi che la sua voce si è spenta, resta l’eco delle sue domeniche, del sorriso condiviso di un’Italia che si ritrovava nello stesso salotto.
Concludo con una citazione.
“Ogni volta che qualcosa può essere raccontato, diventa reale.” (Roland Barthes). Pippo Baudo ha raccontato un Paese, e così facendo, lo ha reso reale.