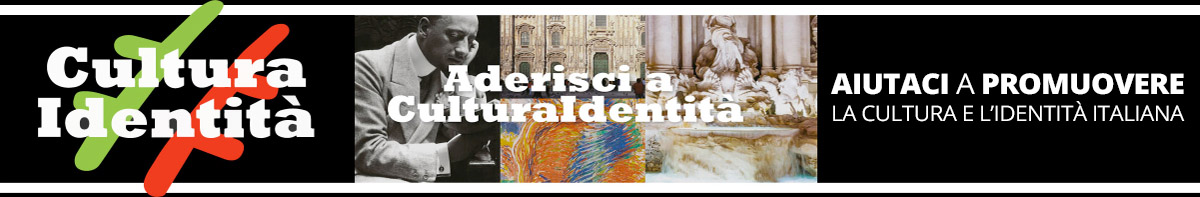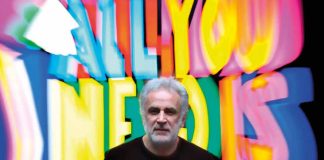Per Sergio Leone il cinema era fuga dalla vita. Un nobile svago ideato da artigiani senza fisime né sofisticherie, capaci di portare – quando va bene – lo spettatore nel mondo della fantasia. Secondo Diego Gabutti, giornalista e scrittore – tra i pochissimi a discettare con eguale competenza di Marx e fumetti, Anarchismo e spy stories -, il regista romano fu un autentico maestro di questo approccio. Ne sono testimonianza le pagine del suo Nel west con Sergio Leone. (Giulio Perrone Editore, 2024). Sorta di mappa dei luoghi leoniani – “un po’ di Cinecittà, un po’ di Calahorra spagnola ma soprattutto, e inconfondibilmente, c’è il deserto, un deserto americano, dunque metaforico” – in cui il maestro appare come l’operaio geniale di una fabbrica chiamata cinelandia, là dove “storia e geografia finiscono” e il sogno diventa film.
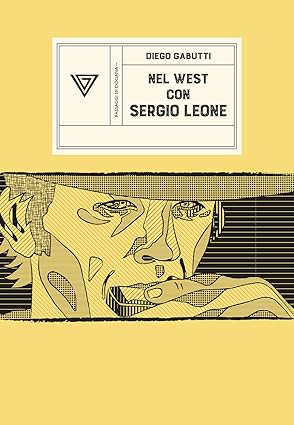
In generale, il libro si presenta come il ritratto affettuoso di un regista che non è stato solo un regista ma l’ultimo cantore di un mondo in via d’estinzione, anche per colpa sua. Parliamo del western, naturalmente: un genere caduto nelle maglie dei nostalgici, o delle operazioni ripescaggio alla Tarantino, che lo stesso Leone ha contribuito a mandare in soffitta (per quanto nei Sessanta e inizio Settanta, gli anni di piena attività del nostro, avesse ancora qualche cartuccia residua da sparare). A dire di Gabutti, lo spartiacque nella storia del western, oltreché la chiave d’accesso di tutta la filmografia del regista, scomparso il 30 aprile 1989 a soli sessant’anni, è rappresentato da C’era una volta il West. Un’Epifania cinematografica dopo la quale nulla sarebbe rimasto come prima, successiva alla cosiddetta trilogia del dollaro (Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo) e realizzata nel ‘68, a compimento di un decennio tempestoso.
Qui, in quasi tre ore di film, l’immaginario narrativo e filosofico di Leone esplode, letteralmente: “Eroi straccioni, spolverini, uno sfolgorante inizio da film muto nella stazione sgangherata in mezzo al nulla, la porta che cigola, le gocce d’acqua che cadono nel cappello di Woody Strode, Jack Elam e la mosca, un Henry Fonda satanico, Charles Bronson mai più così bravo, Claudia Cardinale nella parte più bella e tosta e sexy che le sia mai toccata” e poi “una colonna sonora generosa e poetica come una partitura operistica” firmata dal solito Ennio Morricone. Insomma, se personaggi del calibro di Scorsese, Tarantino e Spielberg lo hanno definito “il film che chiude un’epoca” qualche motivo ci sarà. La trama, in sintesi, ruota attorno alla fattoria “Sweetwater”, unica fonte d’acqua per la ferrovia, e alla sua nuova proprietaria, Jill, che si ritrova contesa tra il magnate delle ferrovie Morton, il suo spietato sicario Frank, un misterioso pistolero, Armonica, e il bandito Cheyenne. Il resto è leggenda.
Per acciuffare il valore profondo del cinema di Leone, Gabutti sceglie di partire dalla Monument Valley americana, location del film, omaggio al “sognatore irlandese” cui allude Armonica, il giustiziere senza nome, cioè John Ford, regista di Ombre Rosse e Sentieri Selvaggi. Se da una parte c’è l’America “dei grandi spazi, prima dell’urbanizzazione, prima del Bronx e delle Chinatown e di Chicago, prima di Las Vegas e della cacciata dall’Eden, prima della Coca Cola e della cocaina”, in cui tutto ebbe iniziò, con The Great Train Robbery, il primo western ufficiale del 1903, e dove tutto non poteva che finire. Dall’altra, l’epica postmoderna del film si gioca sull’unione di ingredienti diversi, essendo un po’ “opera lirica, un po’ poema omerico, un po’ tragedia shakespeariana, ma anche in parte fumetto e persino un po’ cartone animato”. Per dire che C’era una volta il west “riassume l’intero genere western ma insieme lo supera e se ne sbarazza”.
Pensandoci, solo Leone poteva fare una cosa del genere. Da figlio d’arte qual era (suo padre Vincenzo Leone, in arte Roberto Roberti, fu attore e regista oltreché compagno di studi di Gabriele d’Annunzio), dopo anni di apprendistato come aiuto regista (la scena delle bighe di Ben Hur è girata da lui), del cinema sapeva tutto. Ispirato dal muto e dal Giappone di Kurosawa (Per un pugno di dollari è il remake di Yojinbo), il suo orizzonte autoriale, una volta messosi in proprio, comprendeva due obiettivi: “la fuga dalla realtà e la sua intensificazione, il suo rispecchiamento”. A questo servivano i film. Di cosa poi dovessero parlare non era importante. Gli premeva solo che ci fossero problemi morali da risolvere, “l’eterna danza del bene e del male”. Con l’aggiunta di una sfrenata “corsa all’oro”, di una febbre di dollari macchiati di sangue cui (quasi) tutti i suoi personaggi soggiacciono loro malgrado. “Se il denaro, come si legge nei manuali d’economia, è l’equivalente generale di tutte le merci, soltanto il dollaro, tra tutte le monete contemplate dall’ufficio cambi, è l’equivalente generale della sola merce di cui è impossibile valutare il prezzo: l’immaginazione romanzesca”. Ebbene, in questa zona extradimensionale, dice Gabutti, la sola in cui poter mettere in scena contraddizioni, nefandezze, ma anche virtù dell’essere umano, risiede la morale di C’era una volta il west. E, per certi versi, il motivo della grandezza di Sergio Leone. Quel che è rimasto del cinema western dopo il suo passaggio, non a caso, sono “brandelli sfilacciati, come i residui via via più confusi e sfuggenti d’un sogno”. Ad oggi, mai più sognato da nessuno altro.