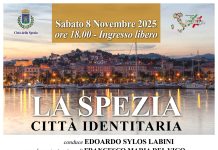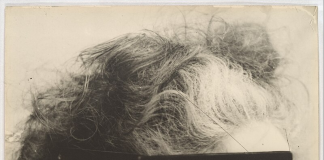ABBONATI A CULTURAIDENTITA’
Condizioni sociali sempre più dure sfociarono in una sentita partecipazione delle campagne briantee agli eventi rivoluzionari del ‘48. Vienna, conscia delle sofferenze del mondo rurale lombardo, aveva tentato negli anni precedenti di promuovere politiche a favore del popolo delle campagne, ma con un intento perlopiù demagogico e divisivo di ceti contadini e borghesia.
Alla notizia dell’insurrezione di Milano contadini armati di rudimentali fucili, zappe e falci, da Monza, Seregno, Desio e altri comuni si radunarono nel capoluogo brianzolo, costituendo la “falange brianzola” che sarebbe entrata a Milano da Porta Comasina. A Monza, il 21 Marzo, l’arrivo di volontari lecchesi diede la carica per vincere sugli austriaci, nonostante un bilancio di 15 morti e 45 feriti tra militari e civili. Annotava un ufficiale austriaco a Monza: “migliaia di contadini armati come avventurieri muovono in Monza per quindi raggiungere Milano”.
L’entusiasmo, però, si affievolì subito: il gruppo moderato che aveva assunto il governo provvisorio provinciale non attuò le misure tanto aspettate dai contadini, che da Missaglia trasformarono l’insoddisfazione in violenza, propagata poi fino a Monticello, Carate e Monza stessa, sedata solo dall’intervento dell’arcivescovo. Radetzky credette allora di poter sfruttare a suo vantaggio quelle insurrezioni contadine, pensando di poter mobilitare a suo piacere le campagne per la causa austriaca. Il Maresciallo si sbagliava: nessun alleggerimento fiscale e il mantenimento della coscrizione, che i più ricchi potevano invece evitare pagando una somma di 300 lire, non spensero il malcontento. Di contro, i moti del ‘48 avevano mostrato agli intellettuali anti-austriaci che una partecipazione popolare sarebbe stata la carta vincente, ma che per ottenerla bisognasse convincere le campagne che uno stato nazionale non avrebbe inasprito fisco e leva.
Anche nelle città la presenza austriaca rimaneva sgradita: acquartieramento di truppe e spese di vettovagliamento gravavano sui bilanci comunali, oltre alle case e alle ville requisite forzosamente per dare alloggio a Corte ed ufficiali. Lo stesso Radetzky nel ‘49 si era trasferito nella Villa Reale di Monza, da dove concesse il rientro in patria ad Emilio Appiani, rivoluzionario fuoriuscito, ma questo non bastò. Appellandosi alla legge marziale, a Monza, dopo gli eventi del ‘48, vennero fucilati i due Rivolta, padre e figlio, colpevoli di aver nascosto fucili e un tricolore. La Corona Ferrea, con la scusa di una “maggiore sicurezza” venne fatta trasferire a Mantova.
Divieto di portare i capelli alla “Garibaldi”. Perquisizioni di ville. Un negoziante monzese bastonato a morte a Milano per aver pronunciato parole di sdegno contro Radetzky.
Anche le municipalità iniziarono a mostrare segni di aperta ostilità alla presenza austriaca. Monza nel 1853, differentemente da Milano e altre province, decise di celebrare il natalizio di sua Maestà senza particolare ossequio: il Podestà e un assessore non promossero particolari iniziative e in Chiesa durante la messa in celebrazione della giornata non presero i posti ufficiali di membri municipali. Questa insubordinazione gli costò il carcere.
A questa situazione oppressiva si doveva aggiungere anche quella della censura austriaca, meticolosa e onnipresente: giovani di Bovisio, Seveso e Cesano vennero arrestati con l’accusa di aver costituito una società segreta perché rinvenuti a passeggiare nei boschi con due preti che impartivano loro il catechismo. Ogni commedia e rappresentazione presso il teatro di Monza (originariamente opera del Piermarini e poi riprogettato da Amati dopo un incendio nel 1810) doveva prima ottenere l’approvazione del commissario austriaco.
Gli austriaci avevano capito che la situazione non avrebbe retto a lungo. Fu così che decisero di elevare Monza al rango di “città regia”. La mossa in realtà era un avvertimento per Milano: una città a soli 15km di distanza, con una sua storia e fama, avrebbe potuto sostituirla se favorita dal governo.
Nonostante questa mossa, la Storia fece poi il suo corso. Nel 1859, precisamente il 15 Aprile, alla vigilia della II Guerra d’Indipendenza, i reali Massimiliano e Carlotta lasciarono Monza, che accolse invece il 10 Agosto il nuovo re Vittorio Emanuele.
(Per approfondire: D. Bonomi “L’etá della restaurazione”, in ‘Storia di Monza e della Brianza’ vol. II, Milano, 1979).