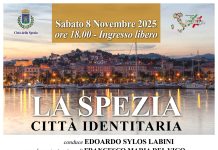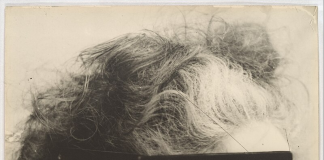Se passi davanti alla chiesa cimiteriale di San Vigilio a Pinzolo, in Val Rendena, non puoi non fermarti davanti alla sua facciata meridionale: lì, dal 1503, la Morte danza da secoli con papi, imperatori, nobili e contadini. È la celebre Danza Macabra di Pinzolo, affrescata da Simone Baschenis nel 1503, pittore della famosa famiglia di artisti itineranti che ha lasciato decine di opere nelle valli trentine.
L’edificio è un esempio di arte architettura cinquecentesca trentina che attrae turisti e amanti dell’arte per la sua bellezza ma soprattutto per la sua celebre danza macabra un affresco imponente, ben visibile dalla strada che da Pinzolo conduce a Madonna di Campiglio volto a ricordare al viaggiatore che la morte colpisce chiunque e in qualsiasi momento. Di sottogronda l’affresco è molto grande e corre lungo tutte le pareti meridionali per la lunghezza dei 21 m come nella vicina chiesa di Carisolo.

Il ballo della morte è stato dipinto per ricordare all’uomo che siamo tutti uguali al cospetto adesso cospetto infatti l’opera è stata commissionata dalla confraternita di abbattuti che nella chiesa di San Vigilio si riuniva per i riti di penitenza. La Danza Macabra di Pinzolo costituisce una delle più significative testimonianze di arte devozionale popolare nell’arco alpino.
L’opera si inserisce nel filone iconografico medievale delle Totentanz, sviluppatosi in Europa a partire dal XIV secolo in risposta ai traumi collettivi della peste e delle guerre. Il termine “Totentanz” (in tedesco: danza macabra o danza della morte) è un concetto artistico, letterario e musicale che affonda le radici nel Medioevo e nel Rinascimento. Si tratta di un motivo iconografico e culturale che rappresenta l’universalità della morte, capace di accomunare senza distinzioni tutti gli uomini: re, papi, nobili, contadini, ricchi e poveri. Simbolicamente è la rappresentazione allegorica della morte come forza ineluttabile, democratica e livellatrice, che non risparmia nessuno.
Aveva un intento morale e didattico; in un’epoca segnata da pestilenze, guerre e carestie, ricordava la caducità della vita terrena e invitava alla preparazione spirituale. Affonda le sue origini nel Medioevo (XIV-XV secolo): si diffonde in Europa, soprattutto dopo la peste nera del 1348. Appare negli affreschi murali (come a Basilea, Lubecca, Clusone) e nei testi poetici e teatrali. Durante il Rinascimento e Barocco il tema si arricchisce di elementi spettacolari e drammatici, sottolineando il contrasto tra la vanità dei poteri terreni e la fine inevitabile.
Nell’ Età moderna e contemporanea il motivo viene ripreso in letteratura, pittura, musica (es. Liszt, Totentanz, 1849) e cinema (ndr. Film IL SETTIMO SIGILLO, Ingmar Bergman,1957) spesso con toni più ironici , esistenziali o sociali.
Il ciclo pittorico si articola in una sequenza di figure che, ordinate gerarchicamente, rappresentano i diversi ceti della società: dal pontefice al contadino. Ogni personaggio è accompagnato o trascinato da una figura scheletrica, simbolo della Morte che, attraverso una sorta di danza macabra, li conduce verso il loro inesorabile destino.
L’elemento dirompente è l’uguaglianza universale che l’affresco trasmette: la dissoluzione delle distanze sociali e la riduzione di ogni potere terreno alla precarietà dell’esistenza umana. Le iscrizioni, in volgare e latino, fungono da commento esplicativo, rafforzando il valore pedagogico e morale dell’opera.
Dal punto di vista stilistico, il lavoro dei Baschenis mostra una commistione tra l’eredità gotica e un primo affacciarsi delle suggestioni rinascimentali: figure schematiche, gestualità vivaci, cromie essenziali che esaltano la leggibilità immediata del messaggio. In tal modo, la Danza Macabra di Pinzolo diviene non solo un memento mori, ma anche un documento prezioso della cultura figurativa e religiosa delle comunità alpine del primo Cinquecento.
La Danza Macabra
“Io sont la Morte/ che porto corona/ sonte signora/ de ognia persona…”
Così inizia il crudo poema della morte che accompagna il celebre affresco della danza macabra
La danza macabra di Pinzolo raffigura il ballo della morte di 18 coppie formate da scheletri e personaggi della società cinquecentesca punto ogni coppia, nella fascia sottostante è accompagnata da didascalie in volgare che indicano i crudeli e a volte spietati avvertimenti della morte il genere umano virgola il Il testo riporta le parole che ogni scheletro che ogni scheletro rivolgi al suo compagno di ballo e sono nella parlata locale, volgare maccheronico di tono popolare, a cui si aggiungono colte citazioni in lingua Latina e volgare sui cartigli portati dagli scheletri. Il dipinto si si legge da sinistra verso destra che può essere diviso in tre parti la prima parte è costituita da un gruppo di tre scheletri che rappresentano il Regno della morte e suonano te strumenti 2 1 è incoronato nel seduto su un trono mentre suona una cornamusa mentre gli altri stanno in piedi e suonano delle trombe questa prima parte è seguita da Cristo corri crocifisso, quindi dipinto per ricordare al fedele che neanche lui è stato risparmiato dalla morte era raffigurato a introdurre il ballo però è proprio.
Il corteo macabro inizia con un gruppo di tre scheletri musicanti, il primo dei quali, seduto su un trono rudimentale, porta in testa la corona a simbolo della Morte sovrana, cui deve sottostare la stessa volontà divina secondo le parole attribuite ai Crocefisso: “O peccator pensa de costei/ la me a morto me che son signor de lei!”
Alla sinistra del Cristo si apre la sfilata delle diciotto coppie, ognuno delle quali è formata da un personaggio vivo, socialmente caratterizzato, e da un morto che lo trascina al ballo. I morti raffigurati come scheletri, nettamente definiti, costituiscono l’elemento dinamico della rappresentazione rivelando intraprendenza e aggressività nel ghigno con cui si rivolgono alle loro vittime e nella varietà dei gesti con cui le afferrano per introdurle al ballo. Alla loro vivacità appare debole la reazione dei vivi che esprimono la più tacita rassegnazione. Il contrasto tra l’atteggiamento dinamico dei morti e la quasi immobilità dei vivi è reso più evidente delle didascalie: in forma di monologo, recitato solo dai primi, ne sottolinea la superiorità. La successione delle coppie riflette la rigida concezione gerarchica della società medievale con la sua divisione tra laici ed ecclesiastici. Questi ultimi aprono la sfilata a partire dalle supreme autorità spirituali: il papa, il cardinale, il vescovo, seguiti dal sacerdote e dal monaco. . A Cristo seguono 18 personaggi abbigliati secondo la moda dell’epoca sistemati secondo il rango sociale punto il Papa, un cardinale un vescovo un sacerdote e un frate francescano sono raffigurati nei loro abiti clericali imposte pompose e raffinate ma anche impose uomini e dimesse come nel caso del frate francescano.
Il messaggio che ad essi viene rivolto ribadisce il concetto dell’ineluttabilità della morte. L’assenza di una marcata satira sociale antiecclesiastica e l’ironia pacata testimoniano l’esistenza di buoni rapporti tra la popolazione e il principe vescovo di Trento.
Il macabro corteo continua poi con un certo numero di rappresentanti dell’ordine laico disposti anch’essi secondo una gerarchia che fa seguire all’imperatore il re, la regina, il duca e quindi alcuni personaggi del mondo borghese, come il medico e il ricco mercante. Segue l’imperatore con lo scettro e la mantella del suo rango, una collana e ricca veste, una regina coronata con abito arabescato, un duca con abito da cortigiano, un medico con toga e ampolla, un guerriero armato con alabarda e spada, un ricco avaro che offre un bacile pieno d’oro, un giovane elegante con cappello piumato, un mendicante con le gambe di legno, una monaca con le mani giunte a chiedere pietà, ghigni malefici.
Più avanti a personaggi socialmente connotati si sostituiscono individui che simboleggiano le diverse età della vita umana: giovani, vecchi e un bambino. A tutti la morte ricorda con accenti diversi l’imparzialità del suo operare. una gentildonna, un’anziana e un bambino senza abiti accompagnato da uno scheletro tiene un sonaglio nell’asta punto ogni personaggio trafitto dalla freccia della morte ed è sistemato in pose rigide e timorose, spaventato dallo spirito che lo accompagna e lo invita al ballo con smorfie e ghigni malefici
Chiude la sfilata l’immagine di una Morte a cavallo, armata di arco e frecce, che saetta nella sua galoppata impetuosa uno stuolo di vittime, in parte già colpite e stese, in parte ancora ritte e impietrite dal terrore corpi ammassati a terra e con l’arco scaglia le frecce sui partecipanti alla danza punto la morte eseguita dall’arcangelo Michele ed al diavolo con il compito di giudicare le anime nel giudizio finale l’arcangelo Michele è dipinto con spade bilancia intercede a difesa delle anime sopra di lui un Angelo sostiene un velo dal quale emerge un’anima 9, sotto sta la scritta morte non può distruggere chi sempre vive tu sei virgolette punto il diavolo, ultima figura della lunga danza, dipinto in sembianze demoniache con ali di pipistrello, enorme orecchie, corre corna e barba da caprone e tiene in mano un libro con l’indicazione dei 7 peccati capitali. Quest’ultimi sono illustrati nella fascia sottostante sono simboleggiati da animali ma purtroppo sono di difficile lettura perché degradati negli anni dagli agenti atmosferici questa è la breve descrizione.
A questa scena il Baschenis fa seguire come epilogo un quadro del Giudizio finale che, ricollegandosi al motivo della crocifissione iniziale, intende inquadrare così l’intera rappresentazione macabra nei termini della visione escatologica cristiana.
L’affresco non propone solo uno degli elementi più significativi della storia medievale trentina, ma assume il carattere di un’allegoria della morte universale che arriva fino a noi, cioè del destino inesorabile a cui nessuna creatura umana può sottrarsi; e in questa problematica esistenziale la morte si ricollega alla vita perché è ammessa come personaggio agente. Nella “unione degli opposti” la sorpresa e lo stupore scompaiono e ci rimane solo l’accettazione del tutto che proclama se stesso.
Morte
Io sont la morte che porto corona
Sonte signora de ognia persona
Et cossi son fiera forte et dura
Che trapaso le porte et ultra le mura
Et son quela che fa tremare el mondo
Revolgendo mia falze atondo atondo
O vero l’archo col mio strale
Sapienza beleza forteza niente vale
Non e Signor madona ne vassallo
Bisogna che lor entri in questo ballo
Mia figura o peccator contemplerai
Simile a mi tu vegnirai
No offendere a Dio per tal sorte
Che al transire no temi la morte
Che più oltre no me impazo in be ne male
Che l’anima lasso al judicio eternale
E come tu averai lavorato
Cossi bene sarai pagato
(ndr. tale poema verrà musicato dall’artista Angelo Branduardi nella canzone BALLO IN FA DIESIS MINORE)
La breve descrizione della danza macabra raffigurata nella chiesa di San Vigilio di Pinzolo alle porte del paese sulla strada riconduce a Madonna di Campiglio. Il soggetto qui trattato è uno degli affreschi più più emblematici del Trentino Alto Adige ma anche nella storia dell’arte italiana punto è un affresco raro ma un tempo molto diffuso in tutto il mondo oltralpe dalla Spagna alla Francia fino alla Germania come messaggio per i fedeli a condurre una vita secondo i precetti cristiani.