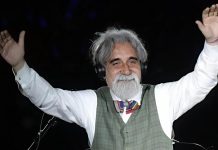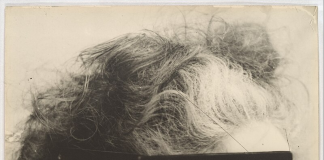ABBONATI A CULTURAIDENTITA’
L’Inferno è il luogo senza la donna amata, il Paradiso è puro Amore
È l’aurora della Pasqua del Signore 1300. Dante e Virgilio sono giunti via terra all’isola del Purgatorio. Nel cielo che ha il dolce colore dello zaffiro orientale brilla «lo bel pianeto che d’amar conforta» che «faceva tutto rider l’orïente» (Purgatorio, I 19- 20). Dante coglie nel sorriso del pianeta Venere un sorriso d’amore: dopo aver attraversato il regno senza amore è come se Dante avesse bisogno di un primo respiro pieno d’amore per riprendere il suo cammino. Il suo viaggio, del resto, era iniziato per amore. Al fondo di tutta l’invenzione della Divina Commedia c’è, infatti, il racconto che in Inferno, II Beatrice fa a Virgilio, e che l’ombra del poeta latino riferisce a Dante bloccato dal dubbio e dal timore nella «diserta piaggia» (Inf., II 62): è il racconto della progettualità divina che giustifica quel viaggio ultraterreno. Per Dante si sono mosse tre donne, Maria, quella che lui stesso ci confessa di pregare ogni mattina e ogni sera (cfr. Paradiso, XXIII 88-90: «Il nome del bel fior ch’io sempre invoco / e mane e sera, tutto mi ristrinse / l’animo ad avvisar lo maggior foco»), Lucia, la donna della luce iscritta per sempre nel suo nome, Beatrice, la donna amata fin dalla puerizia. Si costruisce qui una teologia della persona, nel segno dell’amore. Dunque nella Divina Commedia il kairòs, ‘l’evento salvifico nel quale Dio agisce’, si incarna nella femminilità e Beatrice segno concreto dell’amore disinteressato e discendente di Dio (quello che i greci chiamavano agàpe e i latini caritas) non esita a scendere nel Limbo a muovere Virgilio, al quale dice «amor mi mosse, che mi fa parlare» (Inf., II 72). Se Dio è Amore, l’inferno è il luogo senza amore perché l’uomo, peccando, rompe il suo legame originario e la sua somiglianza con Dio, precipitando così in quella che un grande teologo medievale, Guglielmo di Saint-Thierry, chiama la regione della dissomiglianza. Ciò non significa che in inferno siano assenti l’autorità e la potenza di Dio, perché esse si esercitano come giustizia eterna; ma vuol dire che ogni dannato è irrimediabilmente privato dell’amore di Dio. Il sigillo di questa carta costituzionale è
impresso sulla porta dell’inferno, costruita in principio dalla Trinità creatrice che si declina nella potenza del Padre, nella sapienza del Figlio e nell’amore dello Spirito Santo. Nella storia dell’umanità che precede il momento del giudizio universale, tuttavia, la bontà e la misericordia divine sono tanto grandi che quella porta non è un limite invalicabile per l’amore discendente di Dio: l’ha varcata, come si è visto, Beatrice, e prima di lei Gesù Cristo quando scese nel Limbo a liberare i padri dell’antico testamento. Se l’inferno è il luogo senza amore, non stupisce che, nella mappa topografica che Virgilio disegna sull’orlo del profondo abisso mentre trascorre il tempo necessario a educare l’olfatto di Dante, la parola «amore» torni solo due volte e in una simile espressione – «vinco d’amor che fa natura» (Inf. XI 56) e «quell’amor s’oblia / che fa natura» (Inf., XI 61-62) –, a esprimere proprio il distacco del rapporto Dio-uomo e della somiglianza tra il creatore e le sue creature. C’è però un tipo di amore che interessa particolarmente a Dante ed è la passione erotica, tanto che gli spiriti amanti sono i soli a cui sono destinati spazi in tutti e tre i regni dell’aldilà: nel secondo girone infernale i «peccator carnali» (Inf., V 38), nella settima cornice purgatoriale i lussuriosi espianti (etero e omosessuali con derubricazione di gravità di questo secondo genere di amore rispetto all’inferno), nel cielo di Venere le anime dei beati amanti. Mentre il vento per loro tace, Dante ascolta da Francesca la confessione del proprio «mal perverso», ‘il proprio amore folle e peccaminoso’. Le sue parole sono diventate immortali: «L’amore, che s’accende rapidamente nei cuori sensibili, fece innamorare costui che è qui con me del bel corpo che mi fu tolto; e l’intensità della sua attrazione nei miei confronti ancora mi avvince. L’amore, che fatalmente avviluppa amante e amato, mi fece corrispondere così intensamente alla passione di costui, che – come vedi – ancora non mi lascia. L’amore ci trascinò a una medesima morte. Caina attende l’anima di chi ci uccise». Dante sviene per intensa partecipazione emotiva. La risposta a Francesca avverrà più avanti. Al centro esatto della Commedia (canti XVI-XVII-XVIII del Purgatorio) Dante riserva, infatti, la sua risposta: la concezione cristiana dell’amore che si fonda sul principio dell’anima, creata una, unica e irripetibile dal suo creatore, un Dio che per amore si volge a tanta arte di natura, un Padre che la «vagheggia / prima che sia» (Purg., XVI 85-86), cosicché questa alta e nobile individualità, che è realtà personale, è padrona di sé, ed è soprattutto libera da ogni forma di determinismo, astrale e psicologico. Sarà questo amore che condurrà Dante, guidato da Beatrice, a contemplare quel Dio che è «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par., XXXIII 145).