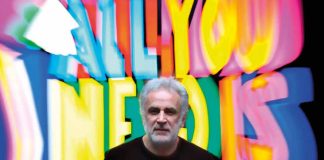Ferragosto è l’anguria fresca, la brace in campagna, il falò in spiaggia, la messa dell’Assunta, le famiglie che si riuniscono. Nel Paese del Sole non poteva che essere una delle festività più amate e identitarie.
Le sue origini risalgono all’antica Roma, quando l’imperatore Ottaviano Augusto, nel 18 a.C., istituì le Feriae Augusti (il “riposo di Augusto”). Questa festa era un periodo di riposo e festeggiamenti per celebrare la fine dei lavori agricoli estivi, considerando che fino all’introduzione delle “Sementi Elette” di Nazareno Strampelli, a maturazione precoce, negli anni Venti del XX secolo, la trebbiatura del grano avveniva a fine luglio. Lo stesso nome di Agosto è derivato dal fatto che l’antico “Sextilis”, il sesto mese del calendario originale romano, era stato consacrato all’Imperatore, per celebrare la sua vittoria su Antonio e Cleopatra avvenuto a metà del mese il 30 a.C.
Nell’antica Roma si tenevano corse di cavalli (da cui i molti palii dell’Italia medievale, fra cui quello storico di Siena), banchetti e momenti di convivialità, dedicati anche a Conso, Dio del Grano, protettore della fertilità e dei raccolti. Durante questo periodo, i lavoratori ricevevano doni e auguri dai loro padroni, una tradizione che si è evoluta nel concetto moderno di “mancia di Ferragosto” che un tempo si dava ai portieri di condominio. Con l’avvento del cristianesimo, Ferragosto assunse un nuovo significato religioso. Nel VII secolo, la Chiesa cattolica collegò la data al dogma dell’Assunzione di Maria, che celebra l’ascesa al cielo della Vergine Maria, corpo e anima, dopo la sua morte, stabilendone definitivamente la data al 15 del mese.

Il 15 agosto divenne così una festa cattolica profondamente sentita, con messe solenni e processioni, specialmente nei borghi marinari, dove la Madonna è venerata come protettrice dei pescatori.
Nel Novecento, durante il fascismo, Ferragosto fu rilanciato come festa popolare. Negli anni ’30, il regime organizzava i cosiddetti “treni popolari di Ferragosto”, che permettevano alle famiglie meno abbienti di viaggiare a prezzi ridotti verso il mare o le città d’arte. Questo contribuì a consolidare la tradizione delle gite fuori porta, ancora oggi tipica del 15 agosto.
Con il boom economico poi le famiglie si sono spesso disperse: i paesi si sono svuotati e i giovani sono emigrati verso il Nord o le grandi città o addirittura all’estero. Ma durante le lunghe ferie estive di cui il nostro popolo ha goduto per decenni (quando eravamo ancora un popolo libero e non eravamo… europei) era consuetudine che ci si riunisse nel paesino, a trovare i vecchi, per incontrare fratelli e cugini e rinsaldare gli antichi legami familiari.
Ed ecco che la tradizione della scampagnata fuori porta è diventata l’occasione per riunire quanti più membri della famiglia, attorno alla festa conviviale. Pranzi in famiglia, picnic, falò sulla spiaggia, spettacoli pirotecnici e sagre locali. Una continuità antica di duemila anni, fra le più genuine e belle tradizioni identitarie della nostra nazione.