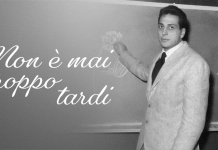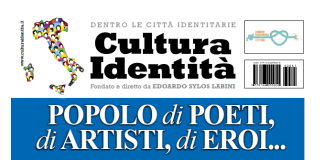Diceva Mario Pirani “il bene assoluto produce il male assoluto”.
Ritroviamo questa citazione in un suo testo, dove affronta alcuni pensieri su Dio e in particolare il Dio di Karol Wojtyla, tra nazismo e comunismo.
Erano queste le considerazioni finali del grande giornalista ed economista Pirani, meditando sul libro che il Papa aveva pubblicato, MEMORIA E IDENTITÀ, in cui il Pontefice, in prima persona, forniva la sua deposizione di superstite di quell’orribile e crudele parabola che la nostra storia recente ha attraversato. Riflessioni delicate e profonde, sulla realtà e l’ideologia del male. In questi suoi pensieri, il Papa si interroga e ne conclude che mentre il nazismo fu male assoluto, il comunismo fu “male in qualche modo necessario all’uomo e al mondo”.
La sperequazione di giudizio fra le due ideologie, comunismo e nazismo, ha da sempre diviso gli animi, portando a polemica le posizioni di storici, intellettuali e non a riguardo, che ancora sono presenti persino tra la destra e la sinistra dei nostri tempi più moderni e in teoria lontani da quel passato che fu attraversato da terribili dittature e vicine invece al mondo che si è andato ad instaurare poi, democratico e liberale, financo ancora oggi, a riverberarsi sul rifiuto da parte di alcuni, del riconoscimento dello Stato di Israele come esito riparatore del Genocidio.
Mario Pirani prosegue che la posizione del Papa è quella del credente, difficile per un laico da comprendere fino in fondo, o comunque difficile da accogliere, in cui si arriverebbe ad accettare il nazismo come punizione divina e il comunismo come il male necessario e in cui infine, il male è segno dell’Onnipotenza di Dio stesso, come sono arrivati ad ammettere mistici e filosofi ebrei.
È dunque la singolarità della Shoah il simbolo di un male assoluto non paragonabile a nessun altro male?
Questo ha però portato, anche secondo Pirani, alla giustificazione politica che si cela dietro ogni altro sterminio, dal genocidio armeno, ai crimini commessi dai regimi comunisti, dai Gulag a Pol Pot. Infatti se è la politica a spiegare la condanna e non posizioni teologiche o posizioni storiche, il comunismo appare infine investito del suo ideale e lo stesso Papa nel citare il Faust di Goethe, scrive del diavolo come «quella forza che vuole sempre il male e produce sempre il bene».
Nonostante i paradossi, Pirani riporta un’altra interessante citazione del Papa Giovanni Paolo II: “Se la libertà cessa di essere collegata con la verità e comincia a rendere la verità dipendente da sé, pone le premesse logiche di conseguenze morali dannose, le cui dimensioni sono a volte incalcolabili”. Qui, diventa dunque il comunismo “quella grande corrente di pensiero e di azione che nel XIX e nel XX secolo si è posta come compito di trasformare il socialismo dalla utopia alla scienza”, con il suo assolutismo di giustizia e di uguaglianza nella missione che fu evangelica nel socialismo, ma dal comunismo tradita e che col comunismo, nella ricerca del paradiso in terra e del “bene comune”, indebolì di fatto ogni azione riformista nel tempo, creando malessere nella società e generando milioni e milioni di morti.
Nonostante il crollo dell’URSS, conclude Pirani, non si è arrivati a comprendere che non c’è nulla di più snaturante che voler cancellare le naturali contraddizioni sociali e dell’individuo, azione questa che porta a commettere atroci crimini contro l’umanità.
“A difendere la libertà ci si rimette sempre”, diceva Curzio Malaparte il quale aggiungeva che però “ci si guadagna sempre qualcosa, se non altro quella coscienza della propria schiavitù, per cui l’uomo libero si riconosce dagli altri. Poiché il proprio dell’uomo, non è di vivere libero in libertà, ma di vivere libero in una prigione”.
Perché tutta questa premessa? Le citazioni che si va riportando sono molte, forse perché la storia si ripete anche se gli eventi possono essere omologhi e mai analoghi.
Questo testo trova a voi lettori immersi nell’epoca della pandemia mondiale, nella post-globalizzazione, nell’incertezza della geopolitica, nella post-politica, nel caos e nel ritorno dei catilinari, comunisti e fascisti che siano, coperti dalle mascherine e in pieno lockdown.
Necessario sarà, si suppone, cercare in qualche modo di fare una pulizia di spirito, senza lasciarsi lavare troppo le mani. Non respiriamo certo l’aria di uomini liberi, forse non tanto per il confinamento forzato a causa della necessità della riduzione del contagio, ma molti altri sono gli aspetti che attanagliano quel fu libero agire dei giorni passati e non troppo remoti. La fatica che la società detta moderna mostra, si riverbera nelle scelte presunte politiche che fanno il paio con la scienza e con alcune posizioni filosofiche e decisioni economiche consequenziali.
È dunque il problema di oggi ancora prima che politico, morale, e richiama in causa tutti coloro che hanno a cuore la libertà.
Per comprendere quanto la libertà abbia un peso nella vita di ciascuno, dell’individuo e nell’insieme di questi nella società, per comprendere quanto importante sia la democrazia e la democrazia liberale, si dovrà partire dal paradossale presupposto che il disprezzo per l’uomo stesso è la vera arma di amore per l’uomo prossimo.
Nel mondo estremamente polarizzato come questo che vediamo, l’individuo e la sua coscienza individuale e quindi la sua libertà con il suo libero arbitrio, si assottiglia, per coagularsi intorno ad estremi di pensiero e vedute che generano male, non bene, generano divisioni e scontro e non unione di intenti. Da una parte ci sono coloro che lo Stato li deve assistere, deve essere onnipresente, dall’altra i sostenitori che il mondo vada difeso necessariamente contro lo Stato che appare opprimente.
Ma cosa fare perché continui ad essere questa una società democratica e liberale?
Proprio per ritornare agli esempi sui totalitarismi di cui sopra, ricordiamo che era Mussolini a dire “Tutto nello Stato, niente fuori dallo Stato, nulla contro lo Stato”, mentre, d’altro canto, Lenin sosteneva “Dove c’è libertà, non c’è Stato”.
Urge dunque la “toilette de l’esprit”, in questo periodo di malattia fisica e morale, politica e sociale. A questo scopo, la cultura, con la conoscenza della storia, resta l’argine più forte e la sua spinta, ferma e contraria, fondamentale.
Esiste intanto un bellissimo dialogo che ha avuto luogo recentemente tra due grandi pensatori e uomini sensibili del nostro tempo, Vittorio Sgarbi e Giulio Giorello.
Giorello riporta perplesso le parole che in data 10 marzo di quest’anno, il Ministro Boccia fa pubblicare dal Corriere della Sera: “arriva un momento in cui i cittadini devono rimettersi totalmente nelle mani dello Stato”.
Viene spontaneo così prevedere le razioni diverse e contrarie che sorgono ad effetto di una tale dichiarazione nell’opinione pubblica, ovvero da una parte chi pensa che lo Stato arrivi in soccorso dei singoli, arrivi ovunque e si ponga come quell’entità invincibile in grado di sconfiggere persino un virus e garantire la sicurezza di tutti, dall’altro, di coloro che respingono con forza tale visione e determinano l’azione di visione opposta, detta populista, convergendo in un’idea di lotta contro le istituzioni.
Ma non dovrebbe essere lo scopo comune, quello di creare le giuste condizioni per instaurare il buon rapporto tra cittadini e Stato, difendere la democrazia liberale e non il contrario ovvero lo scenario in cui lo Stato inglobi il cittadino fagocitandolo o in cui nel cittadino insorga il sentimento di distruggere le sue stesse istituzioni ?
Giorello infatti ammonisce il lettore sulla possibilità, in questo brutto scenario, di un “rinnovato totalitarismo”, che oltrepasserebbe la questione del coronavirus.
Sgarbi, impersonando la vis del critico, ma non troppo, è proprio così che risponde a Giorello, ovvero che “la situazione è grave, ma non seria” (cit. Ennio Flaiano). Secondo il noto critico d’arte infatti, le infelici dichiarazioni dei nostri politici sono frutto di totale inconsapevolezza, non certo parole di consapevoli figuri autoritari.
Sgarbi, pone anche l’attenzione sulla dimensione della scienza e lo spazio che questa si è presa.
Se si riflette, la scienza e la politica sono due cose distinte e non si può far fare alla scienza politica. La scienza sequestrata dalla politica rischia di generare confusione perché si attribuirebbe il diritto del fine morale e politico, come il fu comunismo, e il fine morale e politico nulla ha a che vedere con la scienza.
La verità, ai tempi del coronavirus, resta così coperta da un velo di confusione, i dati uniformi e precisi della scienza non esistono, la comunità scientifica non può certo arrogarsi il diritto del potere decisionale, ci sono dei numeri, ma controvertibili e differenti tra essi, alcuni che non sono nemmeno mai stati utilizzati, non chiari sono gli indicatori e le decisioni vengono di nuovo spostate, in un gioco isterico, dalla scienza sulla politica.
Risultato, una realtà in cui non si risponde con la scienza, ma con misure che riguardano “l’interdizione dei diritti civili e religiosi” persino.
Attacca dunque Sgarbi a ragion veduta, la qualità dell’informazione, che sappiamo centrale nel mondo sociale-virtuale di oggi. Egli pare dunque porre al centro lo spessore della cultura in cui il nostro mondo naviga, e non certo ruota attorno, come dovrebbe essere.
È sancita dalla legge la libertà dei cittadini di riunirsi e liberamente associarsi, per quella che gli inglesi chiamano “deliberation”, ovvero “la lunga e accurata discussione che avviene in seguito ad una riflessione”, in una parola più riduttiva, “dibattito”.
La conversazione intercorsa tra Sgarbi e Giorello poi pubblicata nel libro IL BENE E IL MALE (edito La nave di Teseo) rimette centrale il tema del fine morale della politica e della religione, che la scienza non può avere per sua natura. Una sincera conversazione, in piccolo, un dibattito che avrebbe dovuto forse avere luogo in uno spazio più opportuno e consono rispetto a poche pagine di un libro, una deliberation, cioè la lunga e accurata discussione che avviene in seguito ad una riflessione, che avrebbe come seno naturalmente deputato proprio il Parlamento, in cui oggi si allarga il pensiero unico soffocando le voci di minoranza.
Se un Papa si occupa più della salute del corpo che dello spirito, se lasciamo fare alla scienza la politica, o viceversa, il senso della cura sociale viene necessariamente meno, il dibattito politico inquinato, la democrazia e la libertà soffocate.
Solenne, immacolata, squisita, ma bisognosa e torturata, resta questa silenziosa minoranza, l’arte del dialogo e della politica, il piacere di questo, che attende il momento di restituire alla fantasia, nel senso di apparizione, di manifestazione del pensiero, il giusto spazio che intercorre tra i due fermi poli di intenti che si scontrano oggi e si rivendicano a vicenda, mentre essa, la minoranza, che resta potenza immaginativa rappresentante dell’anima, è preda nella morsa di due opposte non-verità, ovvero meri interessi, senza sfumature.
“Il veleno non piace a coloro che ne hanno bisogno”, si legge in Shakespeare, e ci potremmo riferire alla consapevolezza amara che per reggere e difendere uno Stato si deve essere capaci di conquistarlo, che per conquistarlo serve fatica, non di assediarlo con la forza nella presunta convinzione che questo scagioni dall’inquietudine che è fattore tra i più naturali della libertà, si devono cioè conoscerne le tecniche con cui operare seconda le circostanze e quelle tecniche sono innanzitutto la cultura e l’arte nel senso più ampio, che servono a generare le qualità morali ed intellettuali in difesa delle libertà civili e non in virtù, cioè in difetto, della servitù civile. Poiché in questo Stato debole, che deve difendersi, esso stesso avrà paura delle responsabilità e non sarà più in grado di difendere nemmeno il suo popolo.