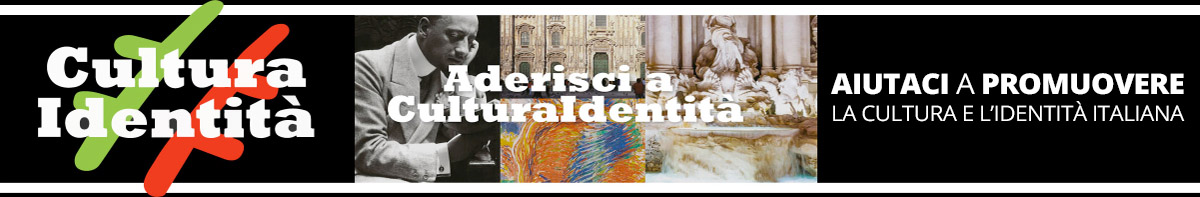Si potrebbe cominciare con la cosa più semplice: il tempo che fa. La nebbia se n’è tutta andata. Resta il freddo di dicembre e un sole ormai sicuro. È questo sole che tocca le tre gocce di lacrime ferme sulla lana nera del mantello. La superficie è una pelle sottilissima, che le fa irrealmente tonde. Tenere e trasparenti, bianche di punte di luce. Esaltate dal nero che quasi non osano toccare – da cui sembra che impercettibilmente si ritraggano. Tre diamanti. La precisione della forma, l’essere sospese, come in noi l’angoscia: della possibilità, della libertà, del dover scegliere e quindi poter cadere. Solo le cose desiderate sono così perfette; solo le cose accidentali sono così delicate. Basterebbe una nuvola in più, un movimento in più o in meno, e il gioiello non sarebbe lì.
Sono quello che resta del pianto di un ragazzo che ha conosciuto per la prima volta la morte vera, di quando ti muore un familiare caro, non letta sulle locandine. Aveva la testa curva nell’abbraccio che lo stringeva al cuore nascosto sotto il mantello di lana nera. Adesso il sole ha ritrovato un passaggio e trasfigura le tre lacrime rimaste appoggiate lì.
Ma la bellezza era cominciata prima. Per almeno tre ore aveva preso la morte e l’aveva impastata con dita delicatissime: togliendo il peso, le deformità, il troppo, aggiungendo dolcezza, profumo, respiro. La rugiada dell’acqua che trasfigura, i movimenti pacati, il canto, il velluto dell’incenso che accompagna le voci verso l’alto. Non il silenzio, la fine, ma questo non finire mai di lavorare la fine come una pasta tenera, un marmo su cui inventare ancora un po’ di levigatezza, una nota da scomporre in altre immense precisazioni del suono. Questo amore moltiplicatore di umanità, anche nel punto in cui l’umano è stroncato, negato, distrutto, marcito. Che non può venire dall’ora e dal qui, ma da una potenza che inventa tempo e spazio per impastarli insieme alla rugiada e al respiro, nel segreto. Non si tratta di credere o di convincersi: basta essere vivi e guardare. Quello che sta facendo il rito è far scorrere fiumi di acqua viva verso la bocca più assetata dell’universo. Credere è rimanere davanti e dentro a quello che sta succedendo – stare in equilibrio appoggiati alla propria pelle, improvvisamente più viva –, senza ritrarsi per la suggestione, a volte così inopportuna, di “logon didonai”, “rendere ragione”. O per paura di non essere i soggetti protagonisti di un produrre efficientistico.
Il quinto procuratore della Giudea non aveva torto con quel suo ghigno (forse un singulto di nichilismo, o terrore): “Che cos’è la verità?”, se Giovanni ha lasciato la domanda rimbombare nei due millenni che ce ne separano, seguita da un silenzio così grande. Appena interviene lo sforzo del produrre un argomento logico, di fronte all’assolutamente necessaria ulteriorità e incontenibilità, ecco l’abisso – Giovanni lo lascia lì perché lo guardiamo bene e impariamo ad assaporarlo.
Il rito impasta con amore la carne dell’uomo, la carne del mondo, non lo lascia nella sua fragile bruttezza: lo consegna a una perfezione che placa e sconvolge; primi tra tutti, gli stereotipi del dire.
L’incenso che rende ovattata l’aria e ripassa i contorni delle cose sfumandoli. Scoprirle nella loro funzione sarebbe un precario antropomorfismo. Così la voce nel canto: avvolge le parole per lasciarle commosse e trasformate. Perché fuori da quel portone chiuso tutto si sbriciola e marcisce – a parte tra le dita degli anacoreti della bellezza, persone che corrono i rischi più grandi, isolate in un bozzolo di silenzio, metà costruito, e, per la metà più grande, subìto.
La terra sta ricoprendo il legno che sigilla la fine di una vita. Il sole si rimpicciolisce dentro le tre lacrime. È il lucore di un’alba. Nessuno ci crederebbe che sia davvero qui, ora, con noi. Con tutto il nostro patire, il nostro cuore sconvolto.
Torno agli ingredienti umani della scena: le lacrime di un ragazzo, il mantello principesco che il rito delle esequie impone, il dolore, la giovinezza, l’Amore increato, il sole, dicembre, il cimitero, con il suo ordine e la sua pazzia, la bellezza, le carezze. Misteri troppo grandi. La luce, il respiro, la rugiada. Giobbe 38-39.
Faccio scivolare le tre lacrime senza incidere la loro pelle sottilissima e tonda che le lacrime non possono avere, come se non osassi toccarle. Le faccio scivolare con amore. Come faccio? Come facciamo? Quella bellezza. Quell’amore.
Tra i riti del venerdì santo c’è il canto di un inno all’albero della croce di struggente sublimità. Gli si chiede:
“Piega i rami, o albero alto,
allenta le tue membra tese,
e si ammorbidisca la durezza
che ti diede la natura,
per distendere su un dolce legno
le membra del re del cielo.”