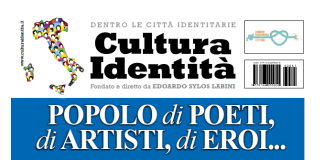“Il nostro motto deve essere: torniamo al canto gregoriano e alla polifonia palestriniana e proseguiamo su questa strada!”. Così rispose Domenico Bartolucci in un’intervista a “L’Espresso” del 2006, poco dopo l’elezione di Benedetto XVI al Soglio Pontificio che sembrava potesse far sperare in una Chiesa con un corso diverso. Dieci anni fa scompariva questo grandissimo musicista, probabilmente il massimo interprete della polifonia della Scuola romana e uno dei più grandi compositori partoriti dal nostro paese nel XX secolo. Forse l’ultimo.
Nato a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, il 7 maggio 1917, iniziò a comporre giovanissimo, a soli 14 anni. Presi gli ordini religiosi, divenne maestro di cappella prima a Firenze, poi a Roma, dove passò per Santa Maria Maggiore per approdare infine alla Cappella Sistina, allora diretta da Lorenzo Perosi (1872-1956). E nel dopoguerra fu il successore di Perosi alla direzione del coro personale del Papa, che seppe rinnovare radicalmente. Bartolucci mandò in pensione gli ultimi castrati – retaggio di un’epoca ormai chiusa – e con la collaborazione di un altro religioso musicista, il Servo di Maria Vittorio Maria Catena, diede nuovo slancio alla Schola Puerorum. Con il loro lavoro, la Cappella Sistina ritrovò lo slancio e la grazia vocale del Bel Canto all’italiana: voci solo maschili come da tradizione millenaria e raffinatissime secondo lo stile della Scuola romana. Diretti da Bartolucci ed educati da Catena, i pueri cantores furono una delle meraviglie dell’Italia che risorgeva dalle ceneri della guerra, affiancati da voci virili adulte di primissima qualità musicale.
A Bartolucci tuttavia toccò in sorte di dover condurre il coro che tanto amava negli anni della profonda trasformazione della Chiesa. Fu lui a dirigere la Sistina all’apertura del Concilio Vaticano II. Qui, forse per l’ultima volta, risuonarono in San Pietro le note maestose della Missa Papae Marcelli di Palestrina, capolavoro indiscusso della polifonia rinascimentale e monumento alla Chiesa del Concilio di Trento, quando Roma riuscì a riformarsi ponendo un argine all’eresia protestante. Nel Vaticano II invece trionfò il modernismo. Bartolucci masticò male ma obbedì. La sua ferrea disciplina non gli impedì però di compiere anche gesti eclatanti, come quando abbandonò polemicamente il coro nel bel mezzo di una funzione con Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro in cui alla liturgia erano stati aggiunti “balletti e tam-tam”, tuonando “chiamatemi quando è finito lo spettacolo”.
La sua ferrea opposizione alle derive moderniste dei liturgisti postconciliari non gli fu mai perdonata, e nel 1997, con la scusa del raggiungimento degli 80 anni, venne vigliaccamente giubilato dalla direzione della Sistina, nonostante la carica di “maestro perpetuo”. Al Vaticano arrivarono invano le proteste dell’Accademia di Santa Cecilia, dove Bartolucci era docente, del maestro Riccardo Muti e del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Voces clamantes in deserto. Dopo di lui, il coro del Papa non ha più avuto la stessa grandezza, finendo anche infangato in scandali come quello del 2018, quando i suoi cantori parteciparono perfino a una festa hollywoodiana con tanto di selfie con personaggi sopra le righe come Rihanna, non esattamente allineati a quel rigore e rispetto che sono richiesti a un cantore pontificio…
Ma per fortuna sua Bartolucci era già scomparso da cinque anni, e questo ulteriore scempio gli è stato risparmiato. Negli ultimi anni di vita, continuò a comporre, dirigere e insegnare musica. Nel 2010 papa Ratzinger, musicista anche lui, riconoscendo il genio di Bartolucci e il suo sforzo per salvare la solennità della liturgia cattolica, lo creò cardinale: un atto eccezionale, perché Bartolucci era il cardinale più anziano mai creato da un papa. Bartolucci aveva infatti 93 anni e mezzo quando indossò la porpora. Del resto, poco prima che il Maestro venisse messo alla porta del coro della Sistina, l’allora cardinale Ratzinger aveva cercato di incoraggiarlo: “Maestro, tenga duro!”. Ma nemmeno quello che era allora il Prefetto per la Congregazione della Fede riuscì a salvarlo dalla vendetta dei suoi tantissimi nemici d’Oltretevere.
Gli ultimi anni di vita furono funestati dal dolore per l’abdicazione di Benedetto XVI e l’avvento di Bergoglio, le cui riforme distrussero in breve quel poco che s’era salvato della suggestiva magnificenza della musica liturgica. Eppure, le persone a lui più vicine testimoniano che egli continuò tenacemente a scriver musica fino agli ultimi giorni di vita.
La sua produzione musicale è gigantesca, riassunta in ben 49 volumi pubblicati dalle Edizioni Cappella Sistina: messe, mottetti, inni, laudi e madrigali, oratori, una sinfonia e un concerto per pianoforte e orchestra e infine un’opera, il Brunellesco, terminata poco prima della morte e che non è stata ancora mai rappresentata. La sua messa in scena – prevista per i 600 anni della realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze (opera, per l’appunto, di Brunelleschi) – è stata annullata a causa dell’“emergenza covid”. E mai più ripresa.
La dedica dell’opera lirica al grande architetto fiorentino è una delle testimonianze dello sconfinato amore che Bartolucci aveva per la sua terra, la Toscana. Sia le sue composizioni religiose che quelle profane riflettono le suggestioni che il Mugello e la sua gente aveva lasciato nel giovane Bartolucci: dal popolo che cantava antifone in gregoriano durante le messe (sì, cantava, cantava bene e cantava in latino) alla musica popolare dei lavoratori in bottega e nei campi o delle bande in piazza e nel teatro di Borgo San Lorenzo. Un patrimonio che egli stesso riconosceva essere ormai perduto: “All’epoca il teatro del paese aveva due stagioni d’opera l’anno” ricordava il Maestro, con rimpianto.
Nonostante gli sforzi della Fondazione che porta il suo nome, Domenico Bartolucci oggi stenta ancora ad avere quel riconoscimento a cui avrebbe diritto. In vita, aveva cercato di salvare la grandezza della musica polifonica italiana, cacciata dalle chiese, rappresentandola nei concerti. Era un sistema profano per tenere accesa una fiammella spirituale. Eppure un aneddoto testimonia come questa fiammella era riuscita in qualcosa che sembra impossibile, nell’epoca della fuga dalla fede: durante la clamorosa tournée della Cappella Sistina in Unione Sovietica, nel 1977, i teatri del paese del comunismo ateo di Stato si riempivano all’inverosimile per sentire la polifonia cattolica. Al termine dei concerti, molti degli spettatori si accalcavano attorno al Maestro, per complimentarsi. Stringendogli la mano, gli lasciavano segretamente dei foglietti con su scritto “io credo” o “mi sono convertito”. Nessun gruppetto di scout con chitarre e tamburelli ha mai ottenuto questo risultato. Al contrario…