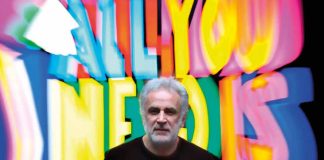Da Canossa a Bengodi un viaggio tra bellezza naturale e tesori enogastromici
Torniamo a Canossa. Letteralmente e col capo cosparso della cenere di un orgoglio punito, come Enrico IV, ai tempi. La sbornia dell’ultramodernità, l’ebbrezza scintillante della supermetropoli di cui ci siamo allegramente ubriacati negli ultimi tre decenni ci ha lasciato solo i postumi, terrificanti, di una solitudine digitalizzata.
Torniamo a Canossa, dunque. E non soltanto lì. Ma anche a Busseto, a Loiano. O a Berceto. L’Appennino emiliano di borghi e villaggi che punteggiano di castelli e duro lavoro la bellezza ineffabile delle vallate verdi che da Parma giungono a Bologna, attraversando il Reggiano, accarezzando Modena. Col loro carico di storia millenaria che, nei secoli ha affascinato, ispirato e tenuto a balia alcuni dei genii assoluti dell’umanità.
A Loiano, nel Bolognese, il fascino dei luoghi e la laboriosità indefessa dei suoi abitanti ispirò al Johann Wolfgang Goethe una considerazione che egli trascrisse nel suo diario di viaggio in Italia e che, qualche anno fa, è stata riportata su una lastra esposta all’ingresso della città in cui, nel brano trascritto si può leggere una descrizione non banale dell’Appennino: “Un singolare groviglio di dossi montuosi contrapposti gli uni agli altri; sovente non si riesce a distinguere in che direzione corrono le acque. Non si deve immaginare un deserto di monti ma una regione ben coltivata, anche se montagnosa”. Terra, dunque, d’agricoltura eppure di allevamento. Di sapori e profumi.
Il formaggio “parmigiano”, del quale si favoleggiava già nelle novelle medioevali del Decamerone quale elemento imprescindibile del Paese di Bengodi, nasce sull’Appennino emiliano. E s’accompagna a un altro sapore che ha conquistato il mondo: quello del prosciutto crudo, proprio di Parma. Da accompagnare coi vini, eccezionali, di queste terre. Il Lambrusco e la Barbera, per esempio.
Nulla nasce per caso. Quella del lavoro duro non può essere solo una retorica, buona magari per far bella figura sulle inutili discussioni social in cui ci si perde quotidianamente. La terra non è nemmeno uno stile di vita, ma una precisa filosofia, un’educazione puntigliosa che, accolta da bambini, non si perde più. Nemmeno tra le luci parigine, di quando Parigi era Parigi e non l’ennesimo capoluogo non più capitale di un Impero d’Occidente sempre più decadente. A Roncole di Busseto nacque e fu educato Giuseppe Verdi, sicuramente tra i più grandi geni musicali del mondo. Seppe conquistare il mondo, Verdi, divenire simbolo di un Paese che allora muoveva i suoi primi passi e scrivere musica talmente potente che resiste ai colpi, dissoluti e stupidi, di chi s’ingegna, per troppo orgoglio o per bassa cucina ideologica, a travisarla. Quando morì lasciò scritto che si edificassero asili e un ospedale a suo nome. Che si trova a Villanova d’Arda e tutt’oggi funziona. Nello stesso borgo visse, per molto tempo, Giovannino Guareschi: il “padre” di Peppone e don Camillo, l’uomo che raccontò per primo l’Italia dilaniata dal conflitto ideologico “freddo” del secondo dopoguerra, senza temere di prendere posizione (e, da giornalista, si fece anche la galera). A Bussetto c’è un archivio storico che lo riguarda.
Per troppi anni s’è visto il ritorno alla terra come una resa, alla meglio come un buen ritiro dopo tanto lavoro, magari in America. Oggi è una necessità. Umana e culturale prima di tutto il resto.