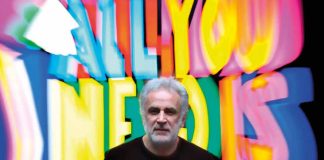ABBONATI A CULTURAIDENTITA’
L’articolo 34 della Costituzione stabilisce che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, aggiungendo inoltre che “la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
In conseguenza del dettato costituzionale, il legislatore ha adottato una serie di testi normativi che disciplinano l’accesso alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per tutti gli studenti iscritti agli atenei italiani.
In sostanza, per tutti gli studenti aventi determinati requisiti di reddito (valore ISEE pari a 23.626,32 euro e ISPE pari a 51.361,58 euro) è possibile accedere ad un concorso per ottenere una borsa di studio, che – eccezion fatta per gli iscritti al primo anno – tiene conto anche del rendimento degli studenti e, più nel dettaglio, dei CFU conseguiti.
La borsa di studio ha un valore nominale di circa 5.200 euro e include il servizio alloggio, il servizio mensa e la quota in denaro; il servizio alloggio ha un valore nominale di circa 2.000 euro, quello mensa, per due pasti, vale circa 1.600 euro mentre la restante parte, pari ad ulteriori 1.600 euro circa, viene erogata in denaro.
Il meccanismo di finanziamento, a causa della continua insufficienza delle risorse previste dal Governo, prevede un cofinanziamento – anche attraverso fondi europei – da parte delle Regioni. Ciò comporta che ove le Regioni non colmino l’insufficienza delle risorse statali, vi sono due possibilità: o gli atenei sono costretti a impiegare risorse di bilancio o emerge la figura dell’”idoneo non beneficiario”.
Questa triste fattispecie ricorre prevalentemente nel Mezzogiorno, dove gli studenti rientranti nel novero dei potenziali beneficiari sono molto più numerosi, a causa dell’ISEE mediamente più basso; per le medesime ragioni socio-economiche, però, è proprio nel Sud Italia che gli Atenei hanno raramente la possibilità di poter attingere a risorse proprie per garantire una borsa a tutti gli Studenti idonei. Motivo per cui emerge la figura dell’”idoneo non beneficiario”: si tratta di quello Studente che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge, non è beneficiario di alcuna borsa solo per insufficienza di fondi.
I servizi per il diritto allo studio vengono erogati attraverso due tipologie di meccanismo: o attraverso un ente regionale appositamente istituto, che opera per tutti gli atenei regionali, o direttamente dai singoli Atenei; il secondo modello, impiegato molto più raramente, è quello adottato – per esempio – in Calabria.
In questa Regione, mediamente, uno studente su due non paga le tasse universitarie in quanto in possesso dei requisiti economici per accedere alla no-tax area o per essere idoneo alla borsa di studio, come nel caso dell’Università della Calabria. In questo ateneo, i servizi per il diritto allo studio vengono gestiti dal Centro Residenziale, ente previsto dal DPR istituivo dell’Ateneo.
È ora il caso di fare un passo indietro. La normativa nazionale fissa alcuni principi fondamentali, contenuti prevalentemente nel D.Lgs. 68/2012: su tutti, la libertà per gli Studenti di scegliere tra quota in denaro e servizi e la proporzionalità tra periodo effettivamente fruito e trattenute applicate al valore nominale.
A tal proposito, in una denuncia di maggio scorso, i Rappresentanti degli Studenti dell’Università della Calabria denunciavano gravi inefficienze e anomalie nell’erogazione di tali servizi: veniva fatto riferimento ai ritardi maturati nell’assegnazione degli alloggi (nella contestuale assenza di qualsiasi misura risarcitoria) e all’impossibilità per gli Studenti di poter scegliere tra parte in denaro e servizi (come, invece, previsto dalla Legge).
La questione dei rimborsi dei servizi non fruiti ha assunto contorni grotteschi durante il lockdown: secondo un accesso agli atti ottenuto dai Rappresentanti, si è registrato un calo dell’82% nel numero di pasti serviti, del 75% nelle presenze negli alloggi e del 60% nelle assegnazioni, per un valore nominale totale in euro pari a circa 8 milioni.
C’è da dire che gran parte di questi fondi proviene dal Fondo Integrativo Statale, erogato dal Governo e ripartito dalle Regioni, che, a differenza di tutti gli altri fondi di finanziamento del Sistema Universitario, contempla gli Studenti quali beneficiari e non gli Atenei.
Ma, oltre all’enormità di tali numeri, il dito viene puntato contro l’inefficienza e la scarsa qualità delle prestazioni generate dall’impossibilità di scegliere tra servizi e la parte in denaro: se lo Studente non è libero di ricevere un contributo per pagare un affitto privatamente, l’Università è libera di assegnare in ritardo l’alloggio o di assegnarlo in condizioni precarie perché, nel caso lo Studente rifiutasse, questo genererebbe un ricavo pari alle spese non sostenute relative alla permanenza dell’alloggiato (lo stesso valga per il servizio ristorazione).
I Rappresentanti degli Studenti, in un incontro tenutosi lo scorso 8 novembre, hanno esposto la vicenda al Ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, e al suo Capo Segreteria, Giuseppe Festinese, durante una loro visita prevista all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
La questione è poi finita in Parlamento con un’interrogazione parlamentare presentata il 3 dicembre dall’On. Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) che, ad oggi, non ha ancora ricevuto risposta.
In tutto questo, migliaia di studenti, perlopiù calabresi o – comunque – meridionali, restano in attesa di risposte tanto dalle istituzioni quanto dalla politica per porre fine ad un’ingiustizia abnorme che circuisce le possibilità e i Diritti di quanti hanno scelto la loro terra e, quindi, la loro identità per costruire il loro futuro.
È questo uno dei casi che dimostra che il progressivo trasferimento di competenze sempre più delicate alle Regioni non ha fatto altro che allontanare il Nord e il Sud della nazione, accentuando le differenze e alimentando il gap tra le aree del Paese.
Chissà cosa direbbero, oggi, i padri costituenti che, pur immaginando il regionalismo, vararono gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Si può certamente affermare che, in casi come questo, il regionalismo sia il miglior nemico della solidarietà, dell’eguaglianza e dell’impegno della Repubblica a rimuovere gli “ostacoli di ordine economico e sociale” che, limitando “la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
È chiaro che non tutti gli Italiani possano avere accesso alle medesime condizioni ai servizi, finanche quelli essenziali, offerti dallo Stato e che non a tutti vengano garantiti i loro Diritti fondamentali allo stesso modo. Neanche quando si tratta di diritto allo studio.