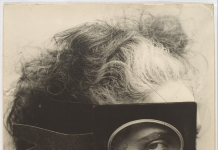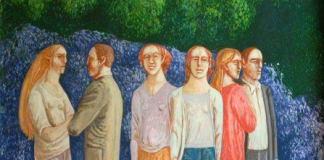Carlo Emilio Gadda avrebbe compiuto oggi 132 anni. È una delle figure più complesse e affascinanti della letteratura italiana del XX secolo. Ingegnere di formazione, combattente nella Prima Guerra Mondiale, intellettuale poliedrico, Gadda si distinse per una scrittura densa, sperimentale e profondamente radicata nella realtà sociale e linguistica del suo tempo che toccò il vertice con “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” (1957), un romanzo che intreccia giallo, satira sociale e riflessione filosofica.
Scritto inizialmente a puntate per la rivista “Letteratura” tra il 1946 e il 1947, “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” fu pubblicato in volume nel 1957 da Garzanti. Ambientato nella Roma fascista del 1927, il romanzo si presenta come un’indagine poliziesca, ma trascende presto i confini del genere per diventare un affresco barocco della società italiana, un’esplorazione della complessità umana e un gioco linguistico senza precedenti. Il titolo stesso, con quel “pasticciaccio brutto”, evoca un groviglio caotico, un intrico di eventi e significati che riflette la visione gaddiana del mondo: la realtà è un “pasticcio”, un insieme disordinato di cause ed effetti, impossibile da ridurre a una spiegazione lineare. La scelta di via Merulana, una strada del centro di Roma, come teatro degli eventi, sottolinea il legame del romanzo con una realtà concreta, brulicante di vita e contraddizioni.
La storia ruota attorno a due crimini commessi nello stesso palazzo di via Merulana: il furto di gioielli in casa della contessa Menegazzi e l’omicidio brutale di Liliana Balducci, una donna borghese senza figli, ma generosa e tormentata. A condurre le indagini è il commissario Francesco Ingravallo, soprannominato “Don Ciccio”, un personaggio complesso, riflessivo, quasi dostoevskiano, che incarna il tentativo (destinato al fallimento) di razionalizzare il caos. Il romanzo si apre con una descrizione memorabile di Ingravallo: “Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti”. Questa “teoria del vortice” è la chiave interpretativa del romanzo: ogni evento è il risultato di una rete di cause, un groviglio inestricabile che sfida ogni semplificazione.
Man mano che l’indagine procede, il lettore si trova immerso in un dedalo di personaggi, sospetti e digressioni: dai popolani romani ai borghesi, dai servitori ai piccoli delinquenti, ogni figura contribuisce al “pasticcio”. Ciò che rende “Quer pasticciaccio brutto” un’opera unica è il linguaggio. Gadda rifiuta la prosa standardizzata, creando una scrittura che mescola registri alti e bassi, italiano letterario e dialetto romanesco, termini tecnici e invenzioni verbali. Il risultato è un tessuto linguistico ricco, stratificato, che cattura la vitalità e la confusione della realtà. Il romanesco, in particolare, è usato per dare voce ai personaggi popolari, ma anche per esprimere l’ironia e il disincanto dell’autore. Frasi come “Quer pasticciaccio brutto” o i dialoghi dei popolani sono carichi di colore e musicalità, ma anche di una profonda malinconia. Gadda, inoltre, si diverte a disseminare il testo di digressioni, descrizioni minuziose e riflessioni filosofiche, che trasformano il romanzo in un labirinto narrativo.
Al di là della trama poliziesca, “Quer pasticciaccio brutto” è un’indagine sulla condizione umana e sulla società italiana. Gadda ritrae un’umanità frammentata, mossa da desideri, avidità e pulsioni inconsce. La Roma del romanzo è un microcosmo in cui convivono ricchezza e miseria, ordine fascista e disordine esistenziale. Il fascismo, pur non esplicitamente criticato, emerge come un’ombra che incombe sui personaggi, un sistema che pretende di imporre ordine a una realtà intrinsecamente caotica.
Gadda nel dopoguerra si professò antifascista e dichiarò di aver abbracciato l’opposizione a partire dal 1934. Eppure come ha scritto Peter Hainsworth, dall’analisi dei suoi scritti dopo il 1934, Gadda fu un «convinto fascista», e solo dopo la caduta di Mussolini e del suo regime si indusse a scrivere astiose pagine polemiche contro il Fascismo: “Il fascismo di Gadda fu ovviamente vissuto all’insegna del nonconformismo” scrive Hainsworth, ma “non costituì un aspetto marginale o fortuito della sua esperienza e del suo lavoro”. “Gadda considerava chiaramente il proprio appoggio al regime calcolato e ponderato. Il fascismo rispondeva al suo bisogno di ordine e di decoro in un mondo che l’esperienza traumatica vissuta durante e dopo la prima guerra mondiale gli aveva rivelato privo d’entrambi”. In questo senso l’antifascismo de “Il pasticciaccio brutto” diventa più una sorta di polemica disillusione, una ripicca di un amante tradito, che non una vera presa di coscienza politica. Ammesso poi, gaddianamente parlando, che le due cose siano differenti, in fin dei conti…