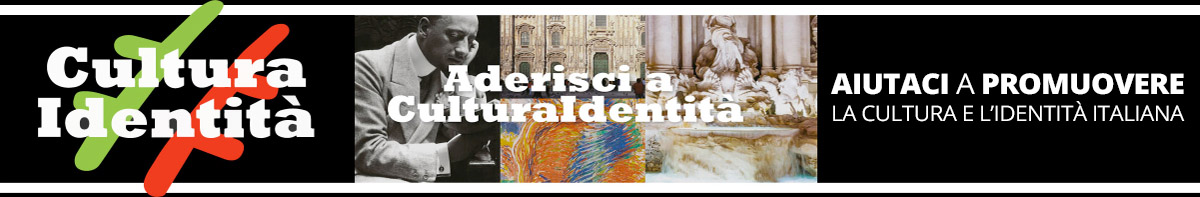L’ermeneutica, o meglio nota come “arte dell’interpretazione”, concerne essenzialmente tre dimensioni: quella grammaticale e specifica, quella figurata ed allegorica e quella più strettamente storica ed applicativa.
Così il borgo, alla luce di queste categorie, può essere sintetizzato in una sorta di affatto velata apologia del proprio statuto, tale per cui, forse, occorre rivalutarlo nella sua interezza rude per provare ad apprezzarne la pastellata -e perciò gustosa- morbidezza selvatica.
Il borgo è perfezione tecnica perché è da sempre fucina di artigianato e di manodopera: qualcosa di recondito perché recondita è la tradizione manuale, la fiamma viva di un bagaglio meticoloso di gesti ripetuti e perciò migliorati, costanti ma elevati, granitici e perciò d’impatto. Il borgo conserva l’ingegno perché deve pensare per procedere; il borgo è statisticamente la ricerca della perfezione perché non conosce lo stratagemma; ed al contempo è pensiero creativo e libero perchè risulta incontaminato dalle catene di negozi soffocanti (e dunque mercato dominante), perché non vive le fasi delle mode ad effetto e perchè deve procreare da sé il proprio nutrimento e fabbisogno ogni volta adattandosi.
Il borgo è tecnicismo perché ogni ricetta della nonna, ogni processione del santo, ogni prodotto tipico messo a stagionare, ogni canovaccio ricucito, ogni bottiglia del vino migliore, ogni potatura collinare, ogni ciclo di stagioni, ogni semina e ogni pioggia, ogni sillaba centillinata di dialetto è tecnicismo da cui non si sfugge. Ed è altresì tecnicismo puro perchè, per aggirare il tentativo di giustificare le sue dimensioni, la sua assenza di comodità meta-lavorative, le sue strade più tortuose, la sua lontananza dal nevralgico di qualche centro dominante, ha dovuto tirare fuori genialità, comprensione e precomprensione, slanci inventivi, aziende veramente incontaminate, prodotti totalmente ottimi, persone veramente perbene: ha dovuto, cioè, dimostrare ogni giorno di poter tracciare la rotta verso l’effettiva specificità che offre, la risoluta linearità con cui produce e lo spirito di genuinità assoluta che lo caratterizza.
Il borgo è, poi, allegoria intesa come purezza di significato, nella misura in cui qualunque istanza assume una naturalezza senza sovrastrutture, una privazione di meccanicismo industrializzato, una componente immediata e mai mediata. Il che significa due cose: il borgo che è vergine dai processi post-moderni di sovrapproduzione e alienazione ed il borgo che è conoscenza contro il misconoscimento che ha appiattito le coscienze. Il borgo riesuma nelle persone l’“invadenza buona”, quel senso familiare che solo chi è vissuto respirando dentro le case di fronte può avere. Il borgo è accoglienza nell’accezione in cui rappresenta il contatto con l’altro, l’offerta di sguardo: qualcosa che manca nelle città e nelle persone che abitano le città. Il borgo è le porte spalancate, quel blaterare fastidioso che però implica l’appartenenza riconosciuta “del figlio del figlio di chi”; è gestazione memetica del sapersi a proprio agio nella sicurezza del posto dove i padri, i nonni ed i genitori dei nonni.
Ed il borgo è, infine, fusione di orizzonti tra chi interpreta e chi è interpretato, ma in che modo? Come può cogliere la paesologia un qualsiasi osservatore prospettico, un comune uomo dalla mentalità strutturale cittadina, un visitatore occasionale, un non abituato alle stradine strette e agli anziani fuori le porte delle case a cucire, mangiare o parlare? Può farlo in virtù di una filosofia della storia, ma al contrario.
Il borgo è la rilettura di un paesaggio in una chiave con efficacia retroattiva perché qualunque persona su questa Terra, qualunque uomo o donna di qualsivoglia età, tornando indietro di qualche generazione appena, ha un borgo nel proprio cuore, cioè un posto in cui permettersi la serenità delle ore che scorrono senza il traffico, il gusto di un pasto antico tra il palato e i denti, un ricordo d’infanzia, una interiorizzazione di senso profondo perduta nelle mura intonacate eppure in piedi, il sacrificio di un avo, la storia archeologica di un sito, i parietali sulle case abbandonate costate un viaggio lontano, la tipicità di un gioiello di rame, la gioia di lasciare liberi a giocare fuori casa i propri figli, il senso di appartenenza, la cronologia museale di anni perfettamente uguali ma percepiti in modo generazionale. O anche qualcosa, che pur avendolo magari privato, di una fertilità lavorativa, gli ha comunque sempre istigato nell’animo due cose: la malinconia di essere andato via e la delicatezza delle cose genuine lasciate a maturare e che qualcun altro ha scelto di raccogliere.
Quella di cui sopra, però, non si limita ad essere un’ermeneutica astratta o lasciata in balia di un senso filosofico, perchè va altresì detto che tale dipinto di angoli incontaminati di esistenza, paesaggi e mestieri è stato, in realtà, per anni lasciato in balia di sé stesso, deprezzato ed accantonato, tenuto a riposo ma non attraverso il coricarsi della lentezza contemplativa, ma messo a sedare, anestetizzato dal poter dire qualcosa, schiavizzato dalla globalizzazione imperante, favorendo il generarsi di una rabbia verso uno Stato che ha incanalato l’alta metropoli senza proteggere il basso borgo.
Non è tuttavia troppo tardi per risanare, tamponare, assistere e comprendere la vita stessa del discorso “paese”. Perché restituire considerazione al borgo, quindi al nucleo pulsante di un’umanità rimasta incolume, significa restituire dignità a quell’Italia che ancora è popolo “di eroi, di santi, di poeti, di artisti, di navigatori, di colonizzatori, di trasmigratori”: cioè di uomini che, in ultima istanza, ri-conosciamo come vicini e quindi non scomparsi.
Elena Caracciolo