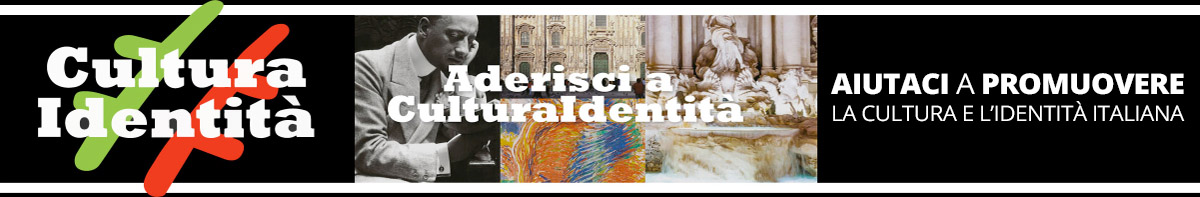Dopo 9 mesi è ancora giusto parlare di emergenza? O l’emergenza si è trasformata in una situazione con la quale dovremmo imparare a convivere? Se dovessimo giudicare dal valore dei provvedimenti economici adottati da questo governo, che con una dichiarazione di Conte del 27 gennaio scorso annunciava “L’Italia è prontissima”, dovremmo dire non solo che non siamo mai stati pronti, ma che nulla è stato fatto per scongiurare il pericolo di questo ‘cigno nero’. Ad oggi, infatti, i quattro pilastri su cui si basa l’azione del governo, sono: cassa integrazione – col contagocce, in 287mila da marzo sono ancora in attesa di riceverla -, il blocco dei licenziamenti, moratoria bancaria e garanzie statali sui prestiti alle imprese. Insomma, non proprio quello di cui ha bisogno l’Italia per ripartire, piuttosto il tentativo di allungare una coperta sul mondo del lavoro, già fin troppo corta. Vecchie ricette a problemi nuovi.
La stessa improvvisazione di Conte e della sua banda nella gestione dell’emergenza sanitaria, la si ritrova nella politica economica, il cui ruolo sarebbe invece fondamentale in questo momento, per aiutare imprese, famiglie e lavoratori ad affrontare l’impatto della crisi economica collegata alla crisi sanitaria. Un’altra occasione persa da parte di un governo che tira a campare soffiando sulle paure degli italiani, incapace di varare riforme di lungo periodo in grado di rendere il sistema Paese finalmente moderno ed efficiente. Ma c’è sempre il rischio di fare peggio davanti al crollo dei fatturati e alla capacità di mantenere gli stessi livelli occupazionali dopo la batosta del lockdown di primavera. Lo sforzo quindi, deve andare in un’altra direzione. Perché davanti al dramma di chi non arriva a fine mese invece di prorogare, sbagliando, le solite misure in salsa assistenzialista, bisognerebbe guardare a investimenti strutturali di lungo periodo. Ad esempio, utilizzando le risorse della cassa integrazione per sostenere quelle imprese che, pur tra enormi sacrifici, sono rimaste aperte nel rispetto delle regole adeguandosi ai protocolli sanitari; per potenziare il trasporto pubblico con mezzi privati invece di ridurre la capienza al 50% così da adeguare l’offerta ed evitare il sovraffollamento; per formare i dipendenti sul rischio del Covid. Soprattutto, premiare chi ce l’ha messa tutta pur di sopravvivere.
Penso alle attività di ristorazione che si sono trovate prima a doversi riorganizzare con le distanze tra i tavoli, i gel igienizzanti, i qr code per i menù digitali, poi la riduzione a 4 del numero dei clienti, e infine con la mannaia della chiusura alle 18. Non sarebbe stato di gran lunga meglio diluire gli orari proprio per consentire, attraverso l’introduzione della prenotazione obbligatoria e del numero chiuso, di lavorare su turni per evitare assembramenti? In questo modo, invece di dare bonus a fondo perduto che pesano come macigni sui conti dello Stato e sul debito pubblico, si sarebbe consentito a migliaia di persone di continuare a lavorare in totale sicurezza. Invece di far fare la fame a milioni di lavoratori – sono 6,5 mln quelli in cig -, li avremmo potuti far lavorare. A beneficio della collettività, perché l’operazione avrebbe significato più tasse incassate, meno debito pubblico e meno oneri. A fine anno, tra cassa integrazione, bonus e fondo perduto avremo speso quasi 60 mld a cui ne vanno sommati altri 24 per finanziamenti garantiti dallo Stato che non verranno mai rimborsati dalle oltre 100mila attività che purtroppo chiuderanno definitivamente i battenti, e avremo 2 mln di disoccupati in più. Proviamo per una volta a rovesciare la logica sulle politiche del lavoro e capire quali sono veramente le battaglie da fare per creare Pil e recuperare la fiducia dei mercati. Oltre c’è solo il baratro.