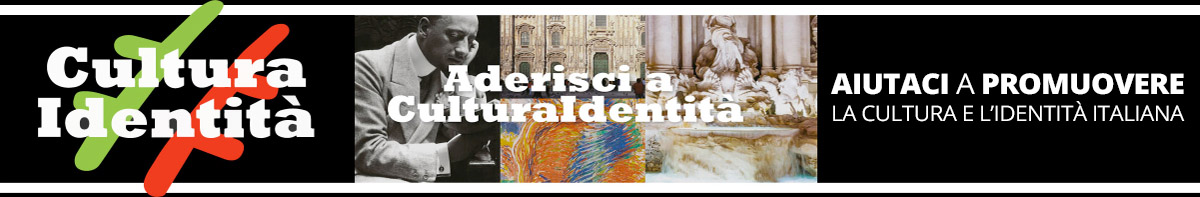Questo non è solo un libro che racconta un momento cruciale della storia italiana. È anche una grande speranza, un invito affinché noi, intesi come italiani, si capisca da dove si viene. E dove si potrebbe andare, se solo si avesse la capacità, diciamo pure la forza politica, di guardare alle cose da una lente prospettica. Una volta si sarebbe detto “sguardo d’insieme” o “visione”. Ma a prescindere dai nominalismi, su cui ci sono già battaglie a sufficienza, si può dire che la qualità che più accomuna i protagonisti di L’Italia del miracolo (Eclettica Edizioni, 2023, pp. 212, € 16,00), volume collettaneo curato da Francesco Carlesi, è proprio la capacità di aver saputo guardare quello che ai più rimaneva celato. E, grazie a questo, essere andati oltre il proprio particolare a favore dell’interesse di tutti. Abbiamo detto “protagonisti”, ma è un termine riduttivo. Dovremmo parlare, semmai, di uomini. Nel nostro caso artefici del miracolo che ha reso l’Italia un paese moderno: parliamo, naturalmente, del cosiddetto boom economico. A cui oramai gli italiani guardano sempre più con mitopoietica fascinazione e un pizzico di nostalgia.

Anche qui, l’espressione invalsa di “boom”, per altro felicissima dal punto di vista comunicativo e giornalistico, sembrerebbe però rimandare più all’istantaneità di uno scoppio fragoroso, a un accadimento improvviso che nessuno poteva immaginare. Invece, scorrendo la vita e le opere degli uomini che questo saggio propone a mo’ di exempla comprendiamo quanto l’Italia uscita dalla Seconda guerra mondiale avesse tutte le carte in regola per competere con le grandi potenze dell’Occidente. Figure quali Federico Caffè, Adriano Olivetti, Amintore Fanfani, Felice Ippolito, Enrico Mattei, Costantino Mortati e Donato Menichella, ancorché cruciali per comprendere la storia di questo paese, fotografano la statura di una classe dirigente unicamente interessata, sembra strano dirlo, al destino dell’Italia.
Come sostiene Benedetto Ippolito nella prefazione: «ciò che forse il mondo di un secolo fa probabilmente non si aspettava più è che l’Italia potesse essere ancora avamposto della genialità umana, apripista del futuro, in un’epoca moderna, segnata dalla tecnologia, dallo sviluppo giuridico, dalla politica industriale».
Fu un momento di rottura inaudito, quello che in poco più di dieci anni, dalla metà degli anni ’50 alla fine degli anni ’60 del Novecento, trasformò il nostro paese, di fatto ancora zavorrato da un’economia prettamente agricola e poco competitiva, in una tra le più ricche nazioni del mondo. Certo, con le sue contraddizioni: pensiamo solo al divario tra Nord e Sud, in termini di crescita, tessuto industriale e investimenti.
Ecco perché, a malincuore, si deve concludere che tale balzo in avanti proiettò l’Italia verso un futuro solo in parte compiuto. Da questo punto di vista leggere L’Italia del miracolo dà come la sensazione che qualcosa si sia interrotto; che se politicamente si fossero prese decisioni più lungimiranti, le cose sarebbero andate in ben altro modo. Quanto queste poi fossero state il frutto di scelte proprie o il risultato di operazioni eterodirette, è difficile dire. Tuttavia, non v’è alcun dubbio che in quegli anni, caratterizzati dall’applicazione del Piano Marshall e in piena Guerra Fredda, ci furono fortissime ingerenze esterne nei settori strategici della nostra economia.
Si prenda il caso di Adriano Olivetti (1901-1960), raccontato mirabilmente da Valerio Massimo Frattale Mascioli, che della sua azienda con sede a Ivrea aveva fatto un capolavoro di efficienza e sperimentazione politica. Pagandone, infine, un prezzo altissimo, se è vero che sulla sua morte ancora oggi, a distanza di più di sessant’anni, non si è mai smesso di congetturare. Ufficialmente fu un infarto a colpirlo sul treno che lo stava portando in Svizzera, da cui poi sarebbe ripartito per il Connecticut, dove aveva sede la Underworld, azienda americana rilevata dalla stessa Olivetti. Proprio nell’intreccio con gli Stati Uniti Mascioli rintraccia le ombre di una morte tuttora inspiegabile: «la Olivetti dava fastidio e tanto: era entrata nel mercato tramite l’Underworld; aveva costruito il primo elaboratore mainframe a transistor del mondo, l’Elea 9003, su iniziativa di Roberto, figlio di Adriano, e grazie al genio dell’ingegner italo cinese Mario Tchou; aveva realizzato il primo computer da tavolo del mondo, il P101 detto “la Perottina”, dal nome dell’ing. Pier Giorgio Perotto che guidò il gruppo di sviluppo; aveva una divisione elettronica tra le prime al mondo, in grado di rivaleggiare con i colossi, in particolare la IBM, e in vantaggio strategico di vari anni sulle concorrenti[..]; cresceva incredibilmente con una modalità tutta sua, coinvolgendo i propri dipendenti e rendendoli partecipi delle iniziative, valorizzandoli, facendoli migliorare e facendoli sentire importanti, una comunità più che una fabbrica, del tutto anomala rispetto al panorama prevalente delle imprese italiane». Autonomia, indipendenza, prestigio internazionale: tratti che definiscono sia l’operato dell’imprenditore piemontese che quello di altre figure presenti nel volume. Come nel caso di Enrico Mattei (1906-1962), grazie al quale il nostro Paese giocò una partita da protagonista indiscussa nel settore degli idrocarburi, fondando nel 1954 l’Eni (Ente Nazionale Idrocarburi). A dispetto della linea ufficiale di totale fedeltà agli Stati Uniti (neoatlantismo), le uniche colpe dell’imprenditore si potrebbero facilmente riassumere in una parola: libertà. Di fare cosa? Di crearsi uno spazio di manovra in campo geopolitico. Si, perché l’Eni «non è stata solo un gigante economico, ma un colosso politico. Soprattutto considerando che agiva nel contesto di una Nazione non produttrice di greggio. Da qui la naturale ostilità delle cosiddette “Sette Sorelle”, ovvero le compagnie petrolifere che controllavano l’intero mercato negli anni Cinquanta. Secondo lo studioso Gastone Saletnich l’Eni negli anni Sessanta era una “realtà internazionale di prima grandezza”». All’enorme influenza acquisita dall’azienda, guardando al Mediterraneo, all’Africa e al Medio Oriente (un piano strategico, come sappiamo, perseguito con forza dall’esecutivo di Giorgia Meloni), si devono aggiungere le capacità di Mattei di aver fatto dell’Eni anche un importante laboratorio culturale (come Olivetti, del resto). Il periodico il gatto selvatico diretto da Attilio Bertolucci, il quotidiano Il Giorno (dove collaborarono alcune delle migliori firme del giornalismo italiano), i documentari aziendali curati dall’Ufficio cinema di Pasquale Ojetti, insomma le attività promosse dal dirigente marchigiano certificavano un disegno complessivo che non riguardava solo il settore energetico ma anche un certo modo di intendere organicamente il lavoro e la vita (di estremo interesse, legata alla vicenda Eni, è la parabola di Donato Menichella, impegnato nel settore nucleare a conquistarsi anch’egli autonomia e margini di libertà). La morte tragica di Mattei, avvenuta il 27 ottobre 1962 precipitando col suo aereo di ritorno a Milano dopo un viaggio in Sicilia, non solo ha sollevato più di un dubbio sull’entità dell’incidente ma ha certamente reso ancora più dolorosa la scomparsa di un vero e proprio “statista” (secondo l’espressione utilizzata dal politologo Giorgio Galli), per quanto egli non abbia mai ricoperto una carica governativa. Dunque, verrebbe da dire, lo stato dov’era? E, soprattutto, all’interno di un ridisegno così significativo della società italiana, quale ruolo doveva esercitare per favorire questa transizione verso un assetto più moderno ed efficiente?
A tal proposito, il saggio dedicato al grande giurista Costantino Mortati (1891-1985) di Gianluca Passera e Francesco Carlesi pone al centro proprio l’idea di uno Stato che, coerentemente con il mandato costituzionale, «deve avere principi, mezzi e possibilità di intervento sul mercato» in quanto «rappresenta la comunità e ne cura gli interessi, anche a scapito del singolo, ponendo dei militi e provando a ottimizzare la distribuzione della ricchezza».
Contro la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, il nuovo assetto sociale dovrebbe prevedere «il lavoro come base di sviluppo della persona, inserito in una società dalla quale il suo operato è interdipendente, che prende forma attraverso uno Stato, quindi la comunità stessa, che abbia la forza, gli strumenti per intervenire e riequilibrare il sistema in favore della socialità».
Oltre lo schematismo rigido tanto del comunismo che del sistema liberista, quindi superando la questione di classe, da una parte, e la visione individualistica di tipo liberale, dall’altra, la costituzione riconosce allo Stato il compito di interessarsi del lavoro come della persona. Essa promuove «un sistema economico misto tra privato e pubblico», con lo Stato coinvolto attivamente nel ruolo di mediatore, attivo nel mercato «correndo in soccorso del capitale privato e dei lavoratori in maniera organica».
Uno Stato per nulla passivo ed assistenziale, dunque, ma che sappia tenere assieme partecipazione e responsabilità quali cardini imprescindibili per il pieno sviluppo dell’individuo. Come il “modello Olivetti”, basato sulla partecipazione diretta all’impresa e sul “conservatorismo sociale”, coniugava la persona e la comunità, allo stesso modo Mortati «reclama uno Stato forte che non si fondi e costituisca nella sovranità formale e autoritaria, ma nella realizzazione dello scopo sociale ed umano per cui esiste». A ispirare l’azione di entrambi, come emerge qua e là dal racconto, fu il filosofo cattolico Jacques Maritain (1882-1973), il quale, non ricordiamo dove, una volta disse: «l’uomo è una persona che si possiede per mezzo dell’intelligenza e della volontà». Se bastasse un aforisma, la ricetta per un nuovo miracolo economico non avrebbe bisogno di altri ingredienti. Facendoceli bastare per un attimo, questo libro induce quasi a credere che l’Italia potrebbe fare tanto di più anche con meno.