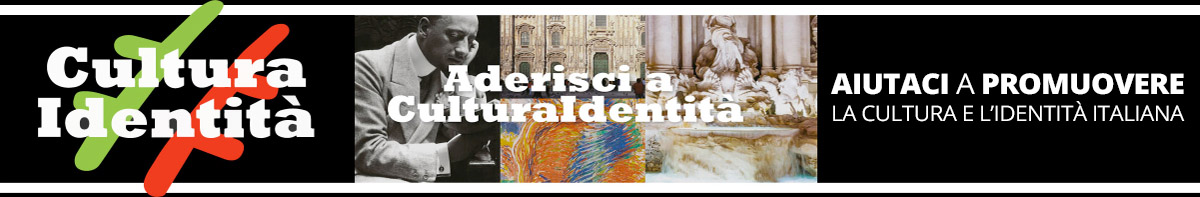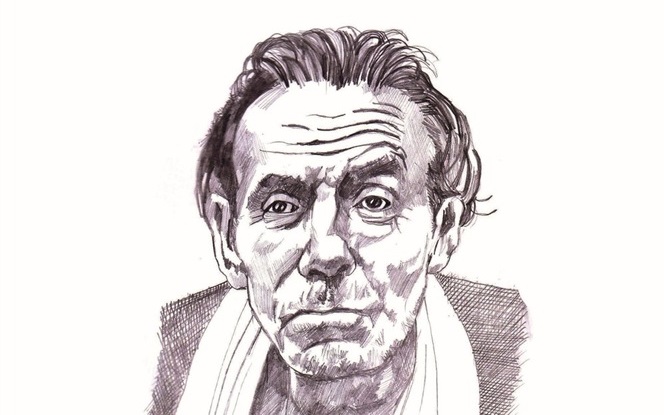“I posteri sono esigenti soprattutto per la loro ipocrisia”. Una ipocrisia che, come scriveva Pol Vandromme, li porta a misurare gli artisti con la lente del moralismo, alla miopia che guarda il passato, o peggio l’arte, con gli occhi del presente. Tralasciando la grande letteratura per motivi politici, non curandosi dello stile, dell’opera. Anche se troppe volte si è perdonata la cattiva scrittura in nome della cattiva politica. Di queste miopie non era però affetto Vandromme, critico belga e cosmopolita, che ha dedicato la sua attività alla diffusione di autori sconvenienti, la cui grande opera non poteva essere eclissata da moralismi. Tra questi Louis Ferdinand Celine, raccontato in uno splendido omonimo saggio edito ITALIA STORICA, curato da Andrea Lombardi. Un saggio necessario per conoscere questo autore dannato capace di scrivere i grandi capolavori del Novecento, come il Voyage o Nord. Un autore riammesso troppo tardi e parzialmente al Parlamento delle Lettere.
Scisso tra il Celine buono dei primi romanzi e quello cattivo dei pamphlets e della trilogia allemande. Vandromme riesce a mettere in luce come, però, questa differenza sia solo apparente, come i libelli, imperdonabili e deplorevoli per il loro contenuto, non possano essere scissi dalla personalità e dallo stile di questo Ezechiele Parigino, poiché “i romanzi raccontano la paura, i libelli cercano di distruggerla”, ma sono figli della stessa atmosfera e dello stesso mondo. Un mondo il cui tema fondamentale è la paura, che si esaspera, si distorce, creando mostri, creando sogni di ossessioni. Ossessioni che sono il lento presagio della morte, della dissoluzione. Di una condizione di putrefazione e fine a cui Celine si illude di sottrarsi attraverso gli esorcismi delle sue pagine. Una paura che si racconta in tutti i testi celiniani e che si manifesta nella “denuncia dell’impostura contemporanea, del lungo combattimento vittorioso che la decadenza stava conducendo contro l’istinto della specie”. Denuncia che si fa atto d’accusa contro la guerra, come la profezia della morte. Una morte che è “l’unica verità della vita”. per cui la guerra è una tragedia, un crimine umanitario senza se e senza ma. Una descrizione della condizione esistenziale amplificata da una lingua espressionista e deformante, che strapiomba negli abissi dell’animo umano, ne vede le mostruosità, le piccolezze. Creando personaggi tra i più veri della letteratura e uno stile che riesce a farsi portatore di una nuova naturalezza. Di una naturalezza che stravolge il linguaggio facendolo il grande megafono delle emozioni. Trasformandolo in un parlato artificiale e vero. Della petite musique che muove l’anima delle tenebre e della notte. Il colore delle fantasmagorie assurde di Guignols band e Morte a Credito, delle liquificazione della parola, della frammentazione e del delirio. Che racconta la folla solitaria, i crepuscoli allucinati del colonialismo, il deserto della guerra, la collera dei bombardamenti, dal Voyage a Nord. Vandromme vivisezione la lingua, i temi e le maschere dell’opera celiniana, tra l’imminenza della paura, la distruzione della guerra e l’innovazione linguistica. Raccontando questo cronista e stilista della decadenza, tra l’ironia di Swift e il cinismo di La rocheufacauld. Compiendo l’esegesi dei romanzi e dei pamphlets, valutati alla luce della loro validità stilistica, sempre considerando l’orrore dei suoi contenuti. Dicendoci che “non dobbiamo avere paura dei suoi libri. La società letteraria deve essere capace di sopportare ogni scandalo e follia, di inghiottire la sua opera e digerire le sue meschinità”. D’altronde come diceva Arbasino, “l’opera d’arte si scrive da sé”. E parla la lingua dello stile e dell’emozione”.