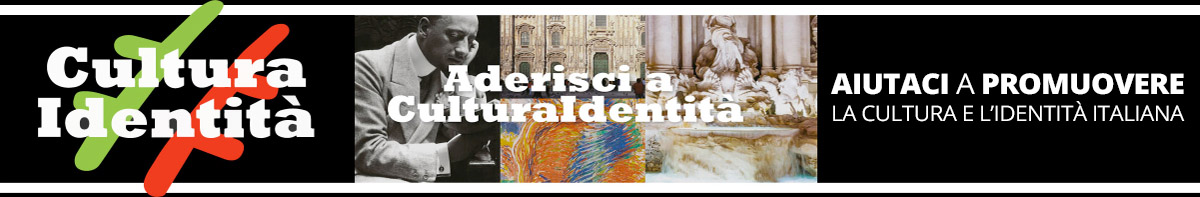Botte, e tante. Prevaricazioni e violenze. Il motivo: il rifiuto d’indossare il velo. L’ultima vittima italiana del diniego dell’educazione islamica è una 14enne originaria del Bangladesh che sabato pomeriggio si è presentata alla stazione dei carabinieri di Ostia per denunciare la madre ed fratello diciassettenne. Era stato proprio il fratello, poco prima che trovasse il coraggio di andare a denunciare, a picchiarla provocandole un trauma cranico e diverse ferite sul volto.
“Mi vogliono mandare in Bangladesh. Non voglio”, ha detto ai carabinieri quando ha denunciato le vessazioni che andavano avanti da tempo. La 14enne voleva una vita occidentale, e per questo subiva maltrattamenti. È alla “sottomissione”, infatti, che corrisponde la reale funzionalità del velo. Nell’ottica degli islamisti, le donne sarebbero il “centro della casa”, dove però è bene che restino rinchiuse. E velate.
La prima volta che l’Europa si scontra con “la querelle del velo” è il 1989. A Creil, lo stesso anno della fatwa contro “I versetti satanici di Salman Rushdie, tre liceali si rifiutavano di togliere il velo in nome del rispetto per la loro religione, l’islam. E nel Paese della laicité iniziava, ufficialmente, l’eterno scontro con l’islam politico. Leila, Fatima e Samira vennero escluse dalle lezioni per l’ostentata pretesa di coprire il capo in nome di Allah.
Un pezzo di stoffa di cui davvero pochi avevano parlato fino a quel momento, inaugurava quella rivoluzione islamica oggi imperante in Europa. Les tchadors de la discorde, fu il pezzo del 9 ottobre 1989 pubblicato su Le Figaro nel quale il corrispondente di allora aveva raccolto le esternazioni delle adolescenti nell’ufficio del preside, “Siamo pazze di Allah, non ci toglieremo mai il velo: lo terremo fino alla morte”. La Francia iniziava ad affrontare il dibattito sociale più lungo della sua storia: sullo sfondo la scuola, gli attori sono delle adolescenti, la religione islamica fa da regista. Quel velo rappresenterà il primo sasso lanciato nel mare dell’islamizzazione e i cerchi concentrici restano infiniti.
È il 2004, e Jean Pierre Obin, accademico francese ed ex ispettore generale dell’istruzione nazionale, viene convocato dal governo. Tocca redigere un rapporto sulle serie sfide che l’islamismo sta imponendo nel mondo della scuola. François Fillon lo riceve e lo cestina in un istante. La paura di toccare il velo e le altre istanze imposte dall’islam è troppo grande. Ma i problemi per la Francia si moltiplicano e il velo resta la sfida quotidiana che l’islam impone agli occidentali.
Eppure lo hijab, storicamente, non ha mai rappresentato un dogma nella religione islamica o un simbolo religioso. Nel 2004, Khaled Fouad Allam sottolineava che il bisogno di ricamare sul velo una teoria del diritto non era proprio contemplato, nell’islam classico, dai giuristi.
Lo hijab, infatti, compare solo nel XIV secolo. E non si trova alcun riscontro effettivo di questa parola nel Corano. Il giurista Ibn Taymiyya è il primo a utilizzarla. E lo fa prendendo spunto da una interpretazione del versetto 31 della sura 24 del Corano. Nell’estrapolare un’affermazione, dal contenuto generico, le attribuisce valore di norma. Diventa strumento politico nel confronto con una popolazione non musulmana.
È così che le campagne a sostegno delle donne velate in Occidente si moltiplicano in breve. Non è solo la moda che cambia le passerelle, ma pure l’Unesco. Due anni fa realizzava un video eclatante, (poi rimosso da YouTube) per incoraggiare le donne ad ostentare le teste velate, “Le donne turche indossano il velo” e una bionda con gli occhi azzurri, “Anche io! È bellissimo!”. Poi lo slogan, “Godetevi la differenza, praticate la tolleranza”.
L’ultima campagna di questo tipo risale a pochi giorni fa. Il velo presentato come emblema di libertà ritorna in una campagna di comunicazione europea, lanciata e poi ritirata in un turbinio di proteste e imbarazzi. “La bellezza è nella diversità come la libertà è nell’hijab”, si legge nel progetto concepito dal Consiglio d’Europa – quella che si presenta come la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del Continente, e riunisce ben quarantasette paesi. Le immagini vedono protagoniste ragazze velate e felici. Gli slogan sono di questo tenore: “Come sarebbe noioso il mondo se fossimo tutti uguali? Celebrare la diversità è rispettare l’hijab”. Una campagna talmente orrenda e pericolosa che ha scatenato reazioni veementi in Francia. Il Consiglio d’Europa s’è visto costretto a ritirare il progetto. Il Consiglio d’Europa non è organo dell’Ue, ma l’Ue compare come sponsor della campagna: la finanzia generosamente e acriticamente, senza considerare il simbolo di oppressione che è quel velo.
Chissà cosa deve aver pensato la nostra quattordicenne di Ostia quando ha visto quelle immagini?
In realtà niente è casuale in questo genere di gaffe: ono il frutto avvelenato di rapporti sempre più stretti che le istituzioni europee stringono con la galassia dell’islam politico legata ai Fratelli musulmani.
Si dà il caso che Femyso, il ramo giovanile di Fioe – organizzazione indicata come struttura paneuropea della Fratellanza- sia stata sponsor proprio di quest’ultima campagna del Consiglio d’Europa.
Il chador, e tutte le sue declinazioni, sono la punta di diamante dell’islamismo e gli dà una visibilità quasi pubblicitaria: non è un caso che la rivolta per il suo sdoganamento in Occidente sia guidata da note modelle islamiche.
La rivoluzione iraniana di Khomeini del ’79 ha avuto un ruolo immenso nella diffusione globalizzata del velo. Ne fece la bandiera del trionfo sugli Usa, quella capace di lavare la umma – la comunità dei credenti – dall’umiliazione della dominazione occidentale. Il che è la misura del suo valore e significato quando è indossato, nella maggioranza dei casi, in Europa.
Dove sono le neo femministe che festeggiano l’8 marzo, mentre condannano le donne musulmane a una condizione di “sottomissione” permanente in nome di un malinteso multiculturalismo?
Intanto la cronaca italiana è stata invasa, solo negli ultimi mesi, da un numero sempre più crescente di episodi simili a quello della quattordicenne del Bangladesh. Nella stragrande maggioranza dei casi l’epilogo, però, è stato il più tragico. Solo una legislazione adeguata può tutelare le donne sottomesse dall’islam.
Una base di proposta c’è già ed è la legge Souad Sbai presentò, nel 2011, alla Camera dei Deputati per l’abolizione di burqa e niqab nei luoghi pubblici. Il testo fu ostacolato da enormi pressioni. Arrivò un’inquietante missiva indirizzata all’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, da parte di presunti convertiti italiani: lamentarono che quel testo aveva in sé un contenuto discriminatorio poiché vietava gli indumenti delle donne musulmane. Tra i firmatari, c’erano tre giovani che sarebbero poi divenuti “foreign fighters” in Siria: Giuliano Ibrahim Delnevo, Aisha Barbara Farina e Maria Giulia Sergio.